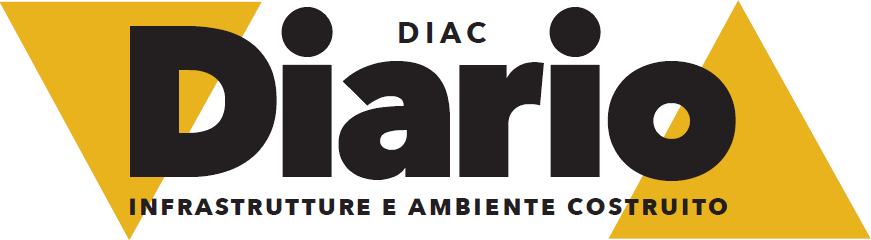L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP / 34
La scelta riparatrice di Wang Shu e Lu Wenyu per una Biennale 2027 meno tecnologica ma più reale dimostra che la geografia dell’architettura è cambiata: il centro non è più l’Occidente

Il problema non era in fondo così difficile da risolvere. Dopo Carlo Ratti e dopo ancora aver nominato curatori che provenivano dal continente africano e dall’America latina, occorreva rivolgersi all’oriente, meglio se alla Cina, da qui la scelta del CdA della Biennale di Venezia, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, di nominare Wang Shu e Lu Wenyu direttori della ventesima Mostra Internazionale di Architettura del 2027. Una scelta, oltretutto, riparatrice che ribalta il Pritzker 2012, che aveva premiato il solo Wang Shu, lasciando in ombra il contributo paritario, e in alcuni passaggi decisivo, di Lu Wenyu.
La Biennale di Venezia, diversamente dal premio americano che evita di riconoscere la natura collettiva del progetto ( si veda anche l’assegnazione del Pritzker al solo Robert Venturi e non alla socia Denis Scott Brown), ha scelto infatti di legittimare entrambi i partner, ammettendo ciò che il mondo dell’architettura sa da vent’anni: Amateur Architecture Studio è una creatura a due teste, e una non funziona senza l’altra.
In tempi in cui le istituzioni culturali oscillano tra timide aperture e dichiarazioni di principio, la nomina di due architetti cinesi è anche un atto politico. Significa non solo banalmente riconoscere che la geografia dell’architettura è cambiata, che il centro non è più l’ Occidente e che l’immaginario del futuro, urbano, costruttivo, ambientale, si sta giocando altrove, soprattutto nelle megalopoli asiatiche. Ma anche affermare che la Cina non è solo il nuovo avversario nello scacchiere geopolitico. O, se vogliamo, che una cosa è lo scontro politico, un’altra il dibattito tra culture diverse.
È qui che Wang Shu e Lu Wenyu diventano figure chiave. Il loro approccio, fondato sul riuso dei materiali, sulla valorizzazione delle tracce della vita quotidiana, sulla riscoperta delle strutture anonime, dei processi artigianali e delle sapienze edilizie vernacolari, sfida frontalmente la retorica delle archistar e dei megaprogetti scintillanti.
È un’architettura della resistenza: resistenza alla tabula rasa urbana, alla perdita di identità, all’omologazione globale. E paradossalmente è un’architettura che capisce che il futuro non sarà fatto solo di nuovi materiali hi-tech, ma di ciò che abbiamo già costruito, di ciò che possiamo trasformare e rielaborare. Le singole identità, salveranno il mondo, più che la globalizzazione e l’omologazione dei comportamenti e delle tecniche.
Se la scelta degli ultimi curatori aveva spesso oscillato tra l’intellettuale sistematico e il progettista–scienziato ( si pensi alla Biennale di Carlo Ratti, dominata da un entusiasmo quasi messianico per il digitale, le reti, l’intelligenza connettiva, la raccolta di dati come nuovo cemento) qui il discorso si ribalta. Ratti ha offerto una Biennale brillante, tecnologica, perfettamente coerente con la sua impostazione da ingegnere della complessità: un archivio-installazione del mondo possibile, dove tutto era misurabile, visualizzabile, ottimizzabile. Wang Shu e Lu Wenyu rappresentano invece la parte non misurabile dell’architettura: che non entra nei grafici, che non produce dashboard colorate, che non si allinea al paradigma dell’efficienza. Nei loro progetti, come il Museo Storico di Ningbo o il Campus di Xiangshan, l’importante non è l’algoritmo ma la pietra recuperata, il mattone rimontato, la continuità tra passato e presente, l’adattamento paziente a un contesto vivo, spesso ferito.
Il confronto è rivelatore. Ratti guarda al futuro attraverso il sensore; Wang Shu e Lu Wenyu lo guardano attraverso la polvere degli edifici demoliti. Ratti vede la città come sistema dinamico; loro come palinsesto sedimentato. Un approccio non contro l’altro, ma sicuramente una svolta di tono: la Biennale con questa scelta sembra voler tornare alla fisicità del costruito, ai muri, alla critica delle demolizioni incontrollate, all’urgenza di una urbanizzazione che in Asia più che altrove procede a una velocità incompatibile con la memoria collettiva.
E qui la scelta dei due direttori diventa ancora più interessante: per la prima volta da anni, la Biennale sembra voler affrontare non solo i progetti, ma la realtà edilizia. Ciò che accade davvero nei cantieri, nelle periferie, nei villaggi in trasformazione, nei quartieri che scompaiono sotto i colpi di bulldozer. Nel loro lavoro, dal restauro della Via Imperiale della Dinastia Song del Sud alla riqualificazione di Wencun, la dimensione teorica non è mai disgiunta da quella materiale.
In questo senso la Biennale 2027 potrebbe portare al centro dell’attenzione temi quali la necessità di un riuso sistematico delle risorse edilizie; il riconoscimento del ruolo degli artigiani e dei saperi tradizionali; la ricucitura dei vuoti prodotti dalle speculazioni immobiliari; la riflessione sulla fragilità del patrimonio costruito non monumentale. Potrebbe perfino introdurre un’immagine dell’architetto meno eroica e più collettiva, dove l’autore è parte di un processo più ampio e condiviso.
L’aspetto straordinario è che tutto questo viene incarnato da due figure che la cultura architettonica occidentale ha spesso osservato con un certo esotismo: i “cinesi che fanno architettura poetica con materiali riciclati”.
Se il programma dei due curatori manterrà fede alla missione implicita in questa nomina, avremo forse una mostra meno tecnologica ma più reale, meno teorica ma più urgente, meno globale in senso cosmopolita e più globale in senso geopolitico. Perché l’architettura non nasce nei convegni, ma dove si costruisce e si distrugge. E oggi, piaccia o no, è in Asia che queste dinamiche si svolgono con la maggiore intensità.
I curatori degli ultimi anni hanno provato a ridefinire l’architettura come disciplina aperta, fluida, interdisciplinare. Wang Shu e Lu Wenyu potrebbero invece ricordarci una verità semplice: prima di essere un linguaggio, prima di essere una teoria, l’architettura è materia. È lavoro.
Leggi gli altri articoli della rubrica "L'Architettura vista da LPP"