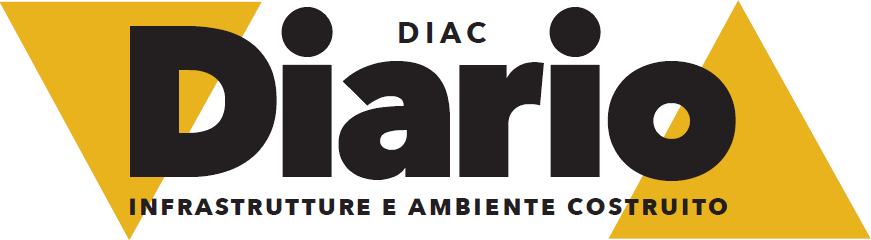L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP / 33
Il riuso e l’architettura che non cancella né restaura, ma manipola, riformula, crea: da Scarpa a Bofill, da Koolhaas a Mendini

Viviamo in un mondo saturo di oggetti, di immagini, di edifici. Abbiamo costruito troppo, spesso male e anche senza chiederci se fosse davvero necessario. Oggi occorre cambiare direzione restituendo senso a ciò che già esiste. E, quindi, recuperare, modificare, interpretare per riformulare la cornice attraverso la quale interagiamo con la realtà che ci circonda, ridando valore alle cose per restituire loro un ruolo nella narrazione del presente.
Recuperare non è restaurare. Il restauro tende a ricomporre un’unità perduta, a riportare l’opera a un presunto stato originario, al “dov’era e com’era” che pervade le nostre norme. Il recupero, invece, è un atto creativo: usa ciò che rimane come materiale per costruire un nuovo edificio. È, per dirla con Nicolas Bourriaud, un gesto di post-produzione. Come un DJ che usa un brano per generarne un altro, l’architetto contemporaneo lavora su ciò che esiste, lo manipola, lo riformula. L’architettura diventa remix, e la città una grande piattaforma di editing.
Alessandro Mendini lo ha teorizzato chiaramente. La sua Poltrona Proust non nasce dal nulla: è una poltrona Luigi XVI, rielaborata attraverso una pittura sgargiante e ironica. Ma in quel gesto nostalgico e dissacrante, in quell’uso del colore che trasforma l’oggetto borghese in icona pop, si nasconde il senso di un’epoca. Un’epoca che non cancella, ma riformula. Il design, e con esso l’architettura, smettono di essere strumenti di tabula rasa e diventano pratiche di riscrittura.
A sottolinearlo è Aaron Betsky, in un recente numero di Domus (n. 1105) dedicato al tema del riuso. Secondo lui siamo di fronte a un nuovo paradigma: quello del riuso creativo. Un’architettura in cui invenzione e memoria convivono, come in un collage digitale. Si prendono frammenti di passato e li si rimonta con gli strumenti del presente. Come quando su Instagram manipoliamo vecchie foto, filtrandole, tagliandole, sovrapponendo layer. L’immagine di partenza resta riconoscibile, ma mutata. Così anche l’edificio esistente non scompare, ma si trasforma.
Gli italiani, come spesso accade, erano arrivati prima. Negli anni Cinquanta e Sessanta, figure come Carlo Scarpa, Franco Albini, il gruppo BBPR e Lina Bo Bardi avevano già superato i limiti del restauro canonico. Non si trattava di ricostruire, ma di far dialogare antico e nuovo. Scarpa, nel Museo di Castelvecchio, interviene con forza: sposta, taglia, incornicia, fa parlare la statua di Cangrande della Scala come mai prima. Il suo non è un gesto di conservazione ma di interpretazione. L’antico brilla di più se lo si accosta al contemporaneo, se lo si mette in tensione con il presente.
Oggi il riuso creativo va oltre. Non vuole più chiarire la storia, ma scriverne un’altra. Lo dimostra Rem Koolhaas con la Fondazione Prada a Milano: una distilleria dei primi del Novecento trasformata in un complesso articolato dove edifici nuovi e vecchi convivono senza gerarchie. “Non è un progetto di conservazione né una nuova architettura”, spiega Koolhaas. È un insieme di frammenti che si confrontano in un’interazione permanente, senza che una parte domini sull’altra. L’esistente non è più fondale, ma attore.
Se volessimo tracciare una genealogia del riuso creativo, potremmo individuarne alcune tappe. La prima, come abbiamo accennato, è quella degli italiani del dopoguerra, il “restauro creativo” che usa il nuovo per far emergere l’antico.
La seconda è la Fábrica di Ricardo Bofill (1973), un ex cementificio vicino a Barcellona trasformato in casa e studio. Le torri di cemento, un tempo destinate alla produzione industriale, diventano quinte poetiche invase da vegetazione. L’archeologia industriale si fa spazio domestico e luogo della mente.
La terza tappa è la casa che Frank Gehry realizza per sé a Santa Monica nel 1978. Una villetta anonima avvolta in lamiere, reti, vetro. Gehry non cancella l’esistente, lo ingloba, lo reinventa. Il risultato è una casa ibrida, irrequieta, con un’anima antica e un corpo nuovo. È il manifesto di un modo diverso di costruire: meno distruttivo, più intelligente. Un recupero che anticipa il decostruttivismo ma anche la sostenibilità, perché riusa invece di demolire.
Negli anni Novanta e Duemila, Bernard Tschumi, Herzog & de Meuron e lo stesso Koolhaas portano il discorso a maturazione. Tschumi, a Fresnoy, costruisce bel 1997 un edificio dentro un edificio, creando spazi interstiziali che sono metafora di un tempo sospeso. Herzog & de Meuron, con la CaixaForum di Madrid (2001–2007), tagliano il basamento di un vecchio edificio in mattoni e lo fanno letteralmente volare, sospeso sopra una nuova piazza. È un gesto di chirurgia architettonica: alleggerire per far respirare. Koolhaas, con la Fondazione Prada (2015), sigilla questa stagione: la foglia d’oro che riveste un vecchio edificio industriale è il simbolo di una convivenza tra mondi, di un dialogo fra rovine e contemporaneità.
Ma i veri maestri del riuso contemporaneo sono Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. Il loro approccio è meno spettacolare, più politico. Non cercano l’icona, ma la qualità dell’abitare. “Mai demolire, mai togliere: sempre aggiungere, trasformare, ampliare”, ripetono. Le loro case, le scuole, gli interventi di edilizia sociale dimostrano che la sostenibilità non è una questione di pannelli solari, ma di intelligenza progettuale. Riusare significa rispettare, valorizzare, moltiplicare. Attraverso strutture leggere, serre, spazi flessibili, Lacaton e Vassal rendono l’esistente migliore, più abitabile, più generoso. In questo senso il loro lavoro è etico prima che estetico: propone un’architettura accessibile, che non spreca risorse e che migliora la vita quotidiana.
E poi c’è il tema dell’effimero, che in Italia resta un tabù. I restauri costano cifre iperboliche e durano decenni. Quando finalmente si concludono, appaiono già superati. Forse dovremmo imparare la lezione della leggerezza: intervenire in modo temporaneo, reversibile, anche provvisorio. Mettere in sicurezza, rifunzionalizzare, restituire all’uso. Non serve sempre la perfezione filologica; serve la possibilità di vivere gli spazi. L’effimero non è precarietà, ma libertà: consente di testare, di sperimentare, di adattare. Un edificio può cambiare funzione, tornare alla rovina, rinascere. È un ciclo vitale, non una condanna.
Il riuso creativo, anche quando è effimero, potrebbe diventare la chiave di volta per l’architettura del prossimo futuro. Perché costruire oggi non significa più aggiungere materia al mondo, ma riconfigurare quella che già esiste. L’architetto non è più solo costruttore, ma interprete. Non progetta ex novo, ma rimonta, post-produce, dà nuova vita ai frammenti. È un regista che orchestra memorie, materiali e desideri.
Forse è questa la lezione più profonda del nostro tempo: il nuovo non si inventa, si ricava. E nel frammento, nell’imperfezione, nella stratificazione del già costruito, si nasconde la materia prima più preziosa per immaginare il futuro.
Leggi gli altri articoli della rubrica "L'Architettura vista da LPP"