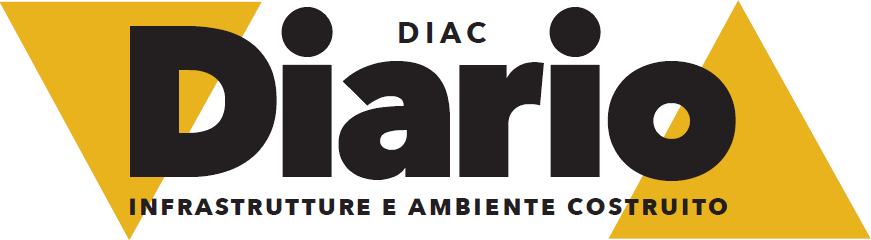L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP / 37
In architettura si copia da sempre senza problemi

«Un bravo artista copia, un grande artista ruba», diceva Pablo Picasso. Una battuta, certo. Ma che, come tutte le battute, contiene una verità, anche se difficile da accettare: l’arte, tutta l’arte, è una catena infinita di furti dichiarati.
In architettura da sempre si copia senza problemi. Nessuno, infatti ipotizza che il tempio A di un santuario della Magna Grecia sia un plagio del tempio B che si trova ad Atene, anche se gli rassomiglia in tutto e per tutto. O che le chiese romaniche disseminate in Europa abbiano scarso valore a causa delle loro notevoli somiglianze. O che, infine, le colonne doriche, ioniche e corinzie compromettano l’originalità degli edifici classici rendendoli simili tra loro.
Anzi, è proprio l’opposto. Si pensa che è così che si costruisce il linguaggio dell’architettura, riconoscendo le radici e allo stesso tempo torcendole, forzandole, contaminandole.
Con il novecento, l’imperativo dell’originalità sembra, però, prendere il sopravvento. Copiare è vietato. Si aboliscono gli ordini architettonici. Mentre il funzionalismo impone una stretta corrispondenza tra le funzioni dell’edificio e la forma, differenziando le diverse tipologie (una scuola è radicalmente diversa da una banca, un edificio abitativo da uno ad uffici).
Ma per quanto si punti all’originalità, i riferimenti alle architetture del passato, più o meno prossimo, non cessano. E non è difficile leggere in numerosi celebri edifici riferimenti ad altri più o meno celebri. Alvar Aalto nel circolo operaio di Jyväskylä copia Leon Battista Alberti, Giuseppe Terragni nel Novocomum si ispira al circolo operaio Zuev di Il’ja Golosov, Curzio Malaparate nella sua casa a Capri ricopia la scalinata della chiesa dell’Annunziata a Lipari.
I riferimenti, tuttavia, tendono a diventare sempre più astratti. Non si copia più l’intero edificio o gran parte di esso ma ci si limita a inserire nel nuovo alcune citazioni. Servono a suggerire affinità poetiche o a sottolineare temi progettuali.
Arrivano così gli anni Settanta e il postmoderno. La citazione diventa adesso un dovere quasi liturgico, un atto dovuto verso i Maestri: Le Corbusier, Mies, Wright. Non li si sfida – sono insuperabili – ma li si “usa come reliquie da esporre e reinterpretare”. È l’epoca del manierismo postmodernista: non costruisco meglio, costruisco dopo. Se non posso batterli perché sono inarrivabili, attraverso la citazione li sfioro e li sorpasso, almeno idealmente.
È in questo nuovo clima che si affermano i Five Architects di New York. Giovani, taglienti come bisturi. Non imitano Le Corbusier: lo sezionano, ne assorbono il purismo, disegnano come lui disegnava. Il più speculativo — il più radicale, e anche il più ironicamente distante dall’idea di edificio come cosa costruita — è Peter Eisenman. Con lui la copia diventa sistema, commento, autocoscienza: un’architettura che parla di architettura.
E mentre Eisenman studia e stratifica, Colin Rowe nota l’ovvio che nessuno aveva osato dire: Le Corbusier aveva già copiato Palladio. Non c’è genio senza genealogia. E allora il percorso appare in tutta la sua chiarezza: Eisenman copia Le Corbusier, Le Corbusier copia Palladio. La copia non è un tradimento: è la condizione ontologica della disciplina.
E non ci sono solo i Five. James Stirling, forse il più vitale di tutti, gioca con l’eredità moderna e storica con un’energia che oggi definiremmo post-irriverente. Smonta, accosta, reinventa.
Poi entra in scena Rem Koolhaas. Non cita il passato, come i nostalgici postmoderni: cita il moderno stesso, come se fosse ancora un campo da esplorare per vitalità e contraddizioni. Il suo modernismo non è revival, ma lavoro sul vivo, sul nervo scoperto della contemporaneità. In lui l’architettura guarda insieme indietro con malinconia e avanti con febbrile curiosità.
Gli anni passano, il manierismo lascia spazio all’eclettismo. L’alfiere di questa stagione è Rafael Moneo. Per lui la coerenza non è nella forma, ma nella qualità. Ogni suo progetto sembra appartenere a un autore diverso: la storia diventa una biblioteca sterminata, accessibile senza vincoli. Moneo lo dichiara esplicitamente nel suo libro Inquietudine teorica e strategie progettuali nell’opera di otto architetti contemporanei (2005). L’architettura contemporanea è un coro dissonante e fertile.
A rafforzare questa deriva contribuisce un fenomeno nuovo: le archistar. Architetti che devono piacere, convincere, sedurre pubblici e committenti in continenti diversi, e che spesso lavorano poco in studio – lasciando che una generazione di giovani collaboratori, formati ovunque e impregnati di stili multipli, orienti le scelte formali. La coerenza linguistica diventa un lusso che non ci possiamo permettere.
L’eclettismo non guarda solo alla storia dell’architettura: si apre all’arte. Gehry dialoga con la scultura, Herzog & de Meuron col minimalismo e il concettuale, Nouvel e Fuksas flirtano con linguaggi plastici e luminosi. L’architettura diventa contaminazione permanente, laboratorio poroso, opera aperta.
Cino Zucchi lo chiama Copycat. E ha ragione. Copiamo e ricombiniamo fino a perdere il filo della citazione. Come nel suo progetto alla Giudecca: chi pensa che stia richiamando la pietra veneziana scoprirà invece riferimenti ai piemontesi Gabetti e Isola. È un gioco di specchi, una genealogia mobile, un albero che cresce intrecciando radici lontane.
Viviamo nella vertigine della copia. Lo ricorda anche il recente volume, scritto da Alessandro Mauro, dal titolo Intersections. Raccoglie cento esempi che dimostrano come l’architettura del Novecento sia stata un gigantesco laboratorio di collage, con risultati più o meno felici. Copiare non è solo parte dell’arte: è l’arte stessa.
E oggi? Oggi la copia si trasforma ancora. Non guardiamo più ai modelli costruttivi, ma alle immagini. L’architettura viene consumata su schermi, compressa in scatti quadrati, catturata dal filtro estetico di Instagram. Non conta la coerenza dell’edificio, ma l’efficacia della singola inquadratura. La casa come fondo per selfie. La città come scenografia per un narcisismo diffuso.
È un male? Certo. Ma – e qui l’architettura sorprende – c’è un rovescio. Inseguendo l’immagine perfetta, si riscopre il piacere percettivo dello spazio. La bellezza o almeno la gradevolezza torna al centro. L’esperienza sensoriale riacquista valore. Nasce l’interesse per le neuroscienze in architettura, segno che abbiamo capito qualcosa di ovvio e rivoluzionario: gli edifici non sono concetti, sono habitat per corpi e menti.
E se ogni tanto la copia diventa farsa, non importa. L’importante è che continui il gioco. Perché l’arte che non copia è un’arte che non vive. E l’architettura è ancora viva, finché continua a rubare.
Leggi gli altri articoli della rubrica "L'Architettura vista da LPP"