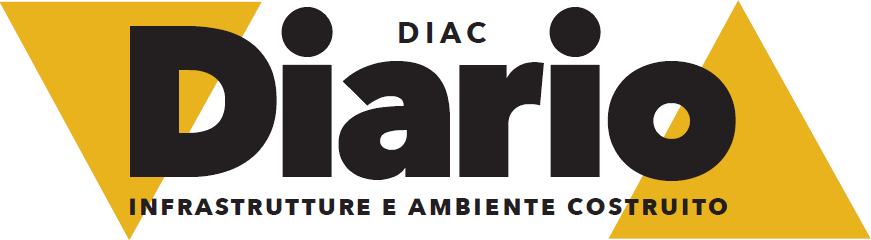LA 59° EDIZIONE DEL RAPPORTO CENSIS
Il lungo autunno industriale nell”Età selvaggia’: il Paese che invecchia e la produttività che scompare, il rischio del declino senza ritorno
In quella che il Censis chiama l’Età selvaggia, l’Italia sembra camminare sul crinale di un declino dove il lungo autunno industriale rischia di scivolare nel gelido inverno della deindustrializzazione (non basta l’antidoto del riarmo). La senilizzazione del mercato del lavoro è il traino del record dell’occupazione. E sale la febbre del ceto medio, nonostante l’arte arrangiatoria degli italiani (nella foto, Giorgio De Rita).

CENSIS. 59 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE 2025
L’Italia vive dentro un’età selvaggia, segnata non più dall’economia come motore della storia, ma da pulsioni profonde: antichi miti e nuove mitologie, paure ancestrali e tensioni messianiche, fedi religiose veementi e fanatismi ideologici, identità radicali e desideri di riconoscimento inappagati. Fenomeni che spiegano più dell’economia il ritorno di guerre, nazionalismi, protezionismi. Il vitalismo irrazionale ha soppiantato l’ottimismo illuminato del progressismo liberal. È la logica del ferro e del fuoco, quella dei predatori e delle prede, che oggi ridisegna il grande gioco politico. Ricorrendo, ancora una volta, a queste locuzioni forti e immaginifiche il Censis ci consegna il ritratto del Paese nella 59ma edizione del Rapporto sulla situazione sociale del Paese presentato, come da tradizione, nei primi giorni di dicembre. E’ un clima dove gli italiani percepiscono sì un’Europa debole nella convinzione nutrita dal 62% della popolazione secondo cui la l’Ue non ha un ruolo decisivo nello scenario globale. Il 53% la vede poi destinata alla marginalità. Ma, intanto, è sempre più forte il distacco dall’american way of life che per il 74% non è più un modello mentre il 55% pensa che la spinta del progresso si sia ormai spostata in Asia. Nello specchio del Censis si riflette, in questo modo, il sentiment degli italiani che ha preso corpo e sta maturando in una fase così complessa e tesa delle relazioni tra le due sponde dell’Atlantico e colpisce in modo particolare perchè, per una coincidenza temporale, questi dati arrivano nei giorni in cui l’Amministrazione Trump ha pubblicato il nuovo documento sulla Sicurezza nazionale, nella versione rivista e corretta in salsa Maga della Dottrina Monroe.
Se questo è lo scenario generale – dove cresce anche l’idea che i rapporti tra potenze si risolvano con la forza (39%) e, per un inquietante 30%, che le autocrazie siano più adatte allo spirito dei tempi-, se questa nuova età della forza domina la geopolitica, penetra anche nell’economia e ne altera gli equilibri. L’Italia ne avverte gli effetti con una struttura produttiva più fragile: consumi reali deboli, mercato del lavoro che invecchia e produttività in calo. È qui che matura il lungo autunno industriale, alimentato anche dall’aumento dei costi dei fattori produttivi. Dal gennaio 2023 all’agosto 2025 la produzione manifatturiera è rimasta in territorio negativo per trenta mesi su trentuno, con due soli rimbalzi episodici. Un terreno fertile per rischi crescenti di deindustrializzazione.Il lungo autunno industriale (e l’antidoto del riarmo). Nella serie nera dei segni meno della produzione industriale hanno fatto eccezione solo tre timidi rimbalzi. In particolare, la produzione manifatturiera è arretrata nel 2023 (-1,6%), nel 2024 (-4,3%) e anche nei primi nove mesi di quest’anno (-1,2%). Il lungo autunno industriale scivolerà nel gelido inverno della deindustrializzazione? Tra i comparti in maggiore sofferenza, quali rischiano di scomparire per sempre? Sono i cruciali quesiti che pone il Rapporto Censis. Nel 2024 solo l’alimentare ha registrato un incremento della produzione: +1,9%. Il tessile e abbigliamento è calato dell’11,8%, i mezzi di trasporto del 10,6%, la meccanica del 6,4%, la metallurgia del 4,7%, la farmaceutica dell’1,7%. Solo quattro comparti (elettronica, alimentare, farmaceutica, legno e carta) mostrano segnali di recupero nel 2025. Contestualmente, nei primi nove mesi dell’anno la fabbricazione di armi e munizioni registra un incremento del 31,0% rispetto all’anno scorso. Quello che arriva dal Censis è, dunque, un nuovo campanello dall’allarme dopo quello suonato nelle scorse settimane dal Rapporto di Confindustria sulla competitività della manifattura che ha posto al centro dell’analisi della criticità, oltre ai punti di forza, del nostro sistema produttivo, dalla cui performance dipendono le prospettive di crescita del Paese.
Altra conferma è quella della senilizzazione del mercato del lavoro. Ormai, puntualmente le rilevazioni dell’Istat registrano la crescita dell’occupazione, arrivata ormai a tassi record, trainata dalla fascia più anziana della popolazione che esce più tardi dal lavoro. La demografia cambia volto all’occupazione, sottolinea il Censis. L’incremento di 833.000 occupati registrato nel biennio 2023-2024 è dovuto prevalentemente alle persone con 50 anni e oltre: +704.000 (ovvero l’84,5% di tutta la nuova occupazione). Il saldo positivo nei primi dieci mesi del 2025 (206.000 occupati in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) dipende esclusivamente dai più anziani, che aumentano di 410.000 unità (+4,2%), a fronte di -96.000 occupati di 35-49 anni (-1,1%) e -109.000 con meno di 35 anni (-2,0%). Tra i giovani sono in netto aumento gli inattivi: +176.000 nei primi dieci mesi dell’anno (+3,0%). Nel biennio 2023-2024 l’input di lavoro supera largamente la crescita dell’economia: +3,7% gli occupati, +5,3% le ore lavorate, solo +1,7% il Pil. Conseguentemente, calano gli indicatori di produttività: -2,0% il valore aggiunto per occupato e -3,5% il
valore aggiunto per ora lavorata.
A fronte di questo processo demografico, il Censis pone un’altra domanda: Rinunciare all’immigrazione? Sono più di 5,4 milioni gli stranieri che vivono in Italia (il 9,2% della popolazione residente), ma la gran parte si trova in condizioni di marginalità. Il 29,0% dei lavoratori stranieri (che sono in totale 2.514.000, ovvero il 10,5% degli occupati) è a tempo determinato o ha un impiego part time involontario (tra gli italiani la quota corrispondente si ferma al 17,2%). Il 29,4% svolge un lavoro non qualificato (l’8,0% tra gli italiani) e il 55,4% degli occupati stranieri laureati risulta sovraqualificato, ovvero possiede un titolo di studio troppo elevato per il lavoro svolto (il 18,7% tra gli italiani). Il 35,6% degli stranieri vive sotto la soglia della povertà assoluta (il 7,4% tra gli italiani). Siamo inclini a guardare con favore gli stranieri quando svolgono lavori faticosi e poco qualificati, o quando accudiscono gli anziani e i bambini, ma non siamo propensi a concedere loro gli stessi diritti di
cittadinanza degli autoctoni. Il 63% degli italiani pensa che i flussi in ingresso degli immigrati vadano limitati, il 59% è convinto che un quartiere si degrada quando sono presenti tanti immigrati, il 54% percepisce gli stranieri come un pericolo per l’identità e la cultura nazionali, solo il 37% consentirebbe l’accesso ai concorsi pubblici a chi non possiede la cittadinanza italiana e solo il 38% è favorevole a concedere agli stranieri il voto alle elezioni amministrative.
Tra le insidie e le minacce ai fondamentali del tradizionale modello di sviluppo italiano pesano anche i fattori endogeni. La regressione demografica, con il progressivo
invecchiamento della popolazione e i tassi di natalità in caduta libera, provoca l’arresto dei processi di proliferazione delle piccole imprese. In vent’anni (2004-2024) il numero dei titolari d’impresa si è assottigliato da oltre 3,4 milioni a poco più di 2,8 milioni: -17,0% (quasi 585.000 in meno). I giovani imprenditori con meno di 30 anni sono diminuiti nello stesso periodo del 46,2% (quasi 132.000 in meno). E se il reddito delle piccole imprese (fino a 5 addetti) corrispondeva al 17,8% del Pil nel 2004, e poi era sceso al 15,7% nel 2014, nel 2024 si è ridotto al 14,0%. Si indebolisce anche l’altro pilastro: il lavoro. Nel 2024 il valore reale delle retribuzioni risulta inferiore dell’8,7% rispetto al 2007. Nello stesso periodo il potere d’acquisto pro capite ha subito un taglio del 6,1%, nonostante il recente parziale recupero (+2,0% tra il 2022 e il 2024). Così il ceto medio vive in uno stato febbrile: nella stagnazione o, peggio ancora, rischia di perdere lo status conquistato nel tempo.
Intanto, tornando sul fronte macroeconomico, il Censis avverte che l’aumento vertiginoso dell’indebitamento delle economie occidentali le rende fatalmente più fragili. Tra il 2001 e il 2024 nei Paesi del G7, a fronte di una stentata crescita dell’economia, il debito pubblico è lievitato dal 75,1% al 124,0% del Pil. In Italia dal 108,5% al 134,9%, in Francia dal 59,3% al 113,1%, nel Regno Unito dal 35,0% al 101,2%, negli Stati Uniti dal 53,5% al 122,3%. Non siamo più l’unico malato d’Europa. Nel 2030 il rapporto debito pubblico/Pil nei Paesi del G7 supererà il 137%, ritornando prossimo al livello raggiunto nel 2020 a causa della pandemia, quando sfiorò il 140%. Si annuncia uno shock per le finanze pubbliche analogo a quello vissuto durante l’emergenza sanitaria, ma questa volta il debito record sarà maturato in
condizioni ordinarie, in assenza di una pandemia. Il ‘Grande Debito’ determina una mutazione ontologica dello Stato: da Stato fiscale a Stato debitore. Gli Stati debitori non potranno abbassare le tasse, obiettivo sempre promesso dagli Stati fiscali e puntualmente disatteso.
L’ingente debito e la bassa crescita, legata all’invecchiamento demografico e alla riduzione della popolazione attiva, congiurano per un inevitabile ridimensionamento del welfare (il welfare state è un fenomeno storico, non imperituro: può nascere e svilupparsi, ma anche estinguersi). Gli interessi pesano come zavorre sui conti pubblici e restringono anche gli spazi di manovra sugli investimenti produttivi e gli stimoli alla crescita. A settembre il debito pubblico italiano ha toccato la cifra record di 3.081 miliardi di euro (+38,2% rispetto a settembre 2001). Nell’ultimo anno la spesa per interessi è stata pari a 85,6 miliardi, corrispondenti al 3,9% del Pil: il valore più alto tra tutti i Paesi europei (ad eccezione dell’Ungheria: 4,9%), anche più della Grecia (3,5%) e molto al di sopra della media europea (1,9%). Gli interessi pagati superano non solo la spesa per i servizi ospedalieri (54,1 miliardi), ma l’intero valore degli investimenti pubblici (78,3 miliardi) e ammontano a più di dieci volte quanto l’Italia spende in un anno per la protezione dell’ambiente (7,8 miliardi). La vulnerabilità è accresciuta dal fatto che i titoli del debito pubblico italiano sono in mano prevalentemente a creditori residenti all’estero: il 33,7% del totale (ovvero più di 1.000 miliardi), a fronte del 14,4% detenuto dalle famiglie e del 19,2% dalla Banca
d’Italia. Il Grande Debito inaugura il secolo delle società post-welfare. Ma senza welfare le società diventano incubatori di aggressività e senza pace sociale le democrazie vacillano. La fiammata inflazionistica del 2022 ha lasciato segni profondi. Tra il 2019 e il 2024 il costo del carrello della spesa è aumentato del 23%, contro un’inflazione generale del 17,4%. Le famiglie spendono di più ma acquistano meno: alimentari +22,2% in valore ma -2,7% in volume; abbigliamento +4,9% ma -3,5% in volume; servizi assicurativi e finanziari +47,3% mentre l’utilizzo cala del 2%. I servizi finanziari puri crescono addirittura del 106,2%.
Insomma, il punto che solleva le principali preoccupazioni è che la compressione dei consumi, l’ invecchiamento del lavoro e la produttività in declino compongono un quadro che supera la congiuntura e tocca la struttura del Paese. Il messaggio è chiaro: senza una strategia capace di rimettere al centro giovani, innovazione, qualità del lavoro e crescita della produttività, l’Italia rischia di scivolare in una traiettoria in cui si spende di più, si consuma di meno e si produce senza crescere. “Resistere, adattarsi, stare dentro le crisi è diventata un’attitudine italiana, nonostante la perdita di potenza dei grandi processi trascorsi di ascesa economica e sociale e di mobilitazione collettiva. Nel saper stare insieme sull’esistente si sfebbrano gli eccessi, si metabolizzano aggressività ed esclusione, si contrastano molte forme di instabilità politica e sociale, si limitano le conseguenze del ritardo di sviluppo economico. Ma − va detto − l’autonoma difesa immunitaria non basta”.