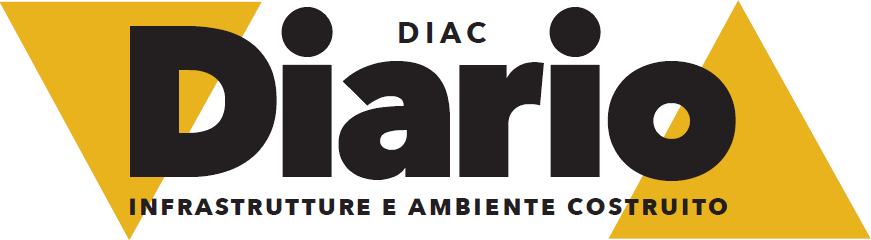PROGETTO CORALE / 23
Prodotti, servizi e ambienti per tutti: la progettazione equa e inclusiva abbandona l’idea di utente medio e diventa Design for All



















Design for All, Universal Design, Inclusive Design, termini diversi e forse in Italia non proprio comuni, volti a indicare in sostanza lo stesso approccio alla progettazione e gestione dei luoghi: equità e inclusione. Il “Design for All” (o “design universale”) è un approccio alla progettazione di prodotti, servizi e ambienti che mira a renderli fruibili dal maggior numero possibile di persone, indipendentemente dall’età, dalle capacità fisiche o da altre caratteristiche.
Con questo approccio la diversità umana, considerata una risorsa e non un problema, viene messa al centro del processo progettuale, e quindi considerata e valorizzata da subito e non “inserita” a posteriori.
Come si legge nella Dichiarazione di Stoccolma dell’EIDD© del 2004, “Design for All è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Questo approccio olistico ed innovativo costituisce una sfida creativa ed etica per tutti i progettisti, designer, imprenditori, amministratori e dirigenti politici.
Design for All ha lo scopo di consentire a tutte le persone di avere pari opportunità di partecipazione in ogni aspetto della società. Per raggiungere questo obiettivo, l’ambiente costruito, gli oggetti quotidiani, i servizi, la cultura e le informazioni – in breve, tutto ciò che è stato progettato e realizzato da persone per essere utilizzato da persone – deve essere accessibile, conveniente per tutti nella società da utilizzare e rispondente alla diversa evoluzione umana.
La pratica del Design for All fa uso cosciente dell’analisi dei bisogni e delle aspirazioni umane e richiede il coinvolgimento degli utenti finali in ogni fase del processo di progettazione.”
Questo approccio supera quindi l’idea di “uomo standard”, abbandonando l’idea di un utente medio e progettando invece per e con una gamma più ampia e diversificata di persone.
Stesso modus operandi che troviamo nell“Universal design”, espressione coniata dall’architetto Ronald L. Mace della North Carolina State University assieme ad un gruppo di collaboratori, per descrivere il concetto di progettazione ideale di tutti i prodotti e gli ambienti artificiali, affinchè siano piacevoli e fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall’età, dalle capacità o le condizioni sociali.
In coerenza con queste metodologie di lavoro, un progetto deve dunque garantire un uso semplice e intuitivo, equo, flessibile dello spazio, che non deve richiedere eccessivo sforzo fisico o conoscenze teoriche e deve risultare attraente e dignitoso per tutti i suoi utenti, secondo il principio che “se non è bello, non è Design for All“.
Ovviamente, per chiunque abbia dimestichezza con il mondo progettuale italiano, è evidente che, nonostante i ricchi apparati normativi, il quadro in cui la progettazione si muove è ancora ben lontano dal garantire una rispondenza piena a questi principi. Le norme, per esempio, contemplano principalmente aspetti di disabilità motoria, ai quali si aggiungono, ma non sempre, solo quelli connessi alla disabilità visiva. Senza che sia chiaro quali competenze progettuali e di verifica servano per l’ottemperanza a queste componenti. Per non parlare della accessibilità in contesti vincolati dalla Soprintendenza, in cui è lecito chiedersi se, nel moderno concetto di tutela che incorpora anche la valorizzazione, consentire la fruizione di un bene a persone in carrozzina sia un obiettivo prioritario o almeno pari rispetto alla valenza percettiva o alla consistenza materica di qualche mq del bene stesso.
Risulta poi molto evidente come l’approccio “Design for all” sia fortemente correlato a tutti i temi di Rigenerazione urbana, proprio per le valenze di equità, inclusione e innovazione che questi processi dovrebbero portare con sé.
Se però è ancora facile individuare in Italia interventi nuovi o di ristrutturazione in cui l’accessibilità è doverosamente contemplata e progettata, per ragionare su un progetto variegato di rigenerazione che sia stato fortemente incentrato sulle tematiche del Design for all questo Diario oggi si sposterà nientemeno che ai Caraibi, nell’isola di Saint Vincent, arcipelago delle Grenadine.
L’arcipelago delle Grenadine, di cui Saint Vincent è l’isola maggiore e la capitale, è stata sullo scacchiere degli scambi colonialisti tra Spagna, Francia e Inghilterra per un paio di secoli. Nel corso del XVIII passa più o meno stabilmente agli Inglesi, che però iniziano la costruzione di un forte, in cima ad un ex cratere vulcanico, per avvistare meglio i potenziali invasori stranieri in arrivo via mare, ma soprattutto i belligeranti ribelli amerindi, fomentati dai Francesi, provenienti dalle montagne dell’interno. Per questa ragione le bocche dei cannoni puntano proprio verso i crinali montagnosi. Iniziato nel 1763, dedicato a Charlotte moglie di re Giorgio III, il forte viene ben presto dismesso come struttura militare per diventare prigione, luogo di raccolta degli schiavi provenienti dall’Africa, ospedale per infettivi e poi, nel secondo dopoguerra, prigione femminile per fedifraghe e donne ribelli. Fino alla completa dismissione negli anni 80 del Novecento, cui segue una sorta di riuso spontaneo per improvvisate guide turistiche e ricercatori di vedute panoramiche. Nel 2021 World Bank decide di finanziare al governo dell’arcipelago il restauro del Forte, per farne un museo di storia locale, l’incarico viene assegnato alla fine dello stesso anno, qualche mese dopo l’eruzione devastante de La Sufiere, il vulcano ancora attivo che domina l’isola. Da subito ai progettisti è chiara la portata di quel progetto, che va ben oltre il recupero delle strutture storiche. Recuperare il forte e renderlo accessibile ad una utenza locale e turistica ha un potenziale sociale ed economico enorme. Può infatti interessare ai croceristi americani, per una visita facile e veloce nelle 5 ore di discesa dalla nave, può interessare al turismo internazionale più curioso, magari in connessione all’orto botanico in cui si trova ancora l’unico albero del pane sopravvissuto all’ammutinamento del Bounty, che proprio a Saint Vincent era diretto per impiantare piantagioni destinate a sfamare gli schiavi dei Caraibi. Può interessare al turismo caraibico, che ama visitare le tracce del passato coloniale e creare reti di memoria tra le varie isole della Regione. Ma può interessare, come luogo identitario, soprattutto alla complessa popolazione locale, fatta di eredi degli amerindi, pronipoti dell’eroe locale che tenne testa agli Inglesi per anni, di eredi degli schiavi approdati qui in cerca di libertà dai territori circostanti, dei pochi Inglesi rimasti sull’isola e degli eredi dei servant indiani dei primi colonizzatori. Una popolazione locale che affronta senza litigiosità il post colonialismo, ma che a scuola non studia storia e che non ha alcun reperto da mettere in mostra nel nascendo museo, per supportare con patrimonio tangibile un percorso intangibile di sopraffazioni, lotte, rivendicazioni, rappacificazioni, povertà e bellezza di cui i vincentiani sono ad oggi poco consapevoli. Ecco che, innanzi a tanta ricchezza e complessità, ai progettisti pare necessario coinvolgere nel progetto chi gestisce le crociere, gli spostamenti interni all’isola e gli hotel, per inserire il forte in una strategia turistica complessiva. E poi coinvolgere i “Lavori Pubblici”, per accrescere l’accessibilità fisica della strada che porta al forte e delle zone di sosta in prossimità, e il National Trust, la cosa più simile alle nostre Soprintendenze, per raccogliere dati sull’heritage di quel luogo e condividerne le idee di valorizzazione. Il progetto di restauro si trasforma così in un laboratorio ampio, che connette memoria e sviluppo e cerca di creare una cornice strategica che abbracci i vari progetti singoli attivi sul territorio. World Bank richiede un progetto basato sui principi dell’Universal Design. Questa diventa l’occasione “formale” per prevedere in primo luogo una accessibilità al sito ai disabili motori, che fino ad ora non hanno potuto nemmeno varcare il cancello di ingresso a causa della ripida salita che conduce ad esso. Non ci sta una rampa, non ci sono altri ingressi, si sceglie allora di affidare il trasporto ad un servizio di golf cart, adatto anche a bambini, anziani, genitori con figli, che sarà gestito da una associazione per l’inclusione dell’handicap, ancora troppo spesso uno stigma in certe culture caraibiche. I numerosi dislivelli interni vengono risolti con una pavimentazione galleggiante che porta tutto sullo stesso piano, la grande rampa che porta in cima ai bastioni viene dotata di parapetti disegnati insieme al National Trust. Per la prima volta, a godere dell’incredibile panorama saranno anche persone in carrozzina.
Così come gli altri arcipelaghi e il vulcano, ben visibili dal forte, saranno descritti ai non vedenti da pannelli appositi, con testi e disegni, posizionati accanto agli immancabili canocchiali panoramici con monetine.
Ma l’inclusione vera, che connota questo progetto, viene fatta con l’allestimento del museo. Da mettere in mostra non c’è nulla, non un coccio, non un disegno. World Bank nel suo bando proponeva un percorso museale fatto di repliche di armi e divise degli Inglesi messe su manichini, ma è evidente a tutti che la storia e la ricchezza di quel sito va ben oltre il breve periodo di uso militare britannico. Si sceglie allora una strada diversa, quella del “museo aperto”, che parte con poco, per svilupparsi come organismo dinamico e vivo, che promuove, raccoglie e racconta le voci della storia e della cultura locale. La prima parte dell’allestimento sono gli stessi materiali da costruzione, “liberati” grazie agli interventi di conservazione. Ci sono le pietre vulcaniche, che raccontano il grande protagonista borbottante dell’evoluzione dell’isola. Ci sono le rocce intagliate e trasportate dagli schiavi, che raccontano la storia degli oppressi, ci sono i mattoni cotti in Inghilterra e giunti fin lì come zavorra delle navi dei colonialisti. Basta una porzione di muro e qualche riga e secoli di vicende e di protagonisti sono svelati. Poi ci sono i costumi, da far realizzare come replica ad artigiani locali, quelli degli inglesi, ma anche quelli dei Kalinago, abitanti precolombiani dell’isola, e dei Black Caribbean, gli ex schiavi. Poi ci sono i diari, che giacciono abbandonati in un magazzino del forte, delle carcerate degli anni ’60, che raccontano la difficile condizione femminile nella fase del post-colonialismo. E poi, per dare vita a tutte le stanze del Forte, si decide di organizzare dei workshop e una “call for objects”, per condividere con gli stakeholders locali questa visione di un museo-specchio della comunità e per raccogliere reperti, dimenticati nelle soffitte di casa, da dare in prestito al museo. E nasce così anche l’idea delle voci: non tutti a Saint Vincent sanno leggere, non tutti i visitatori, locali e non, parleranno inglese. Ecco allora che si decide di coinvolgere la popolazione e registrare racconti di storia locale in diverse lingue, compresa quella Kalinago, di cui non esiste nemmeno una grammatica o un dizionario. E si sceglie di registrare anche la voce del vulcano e quella dell’oceano, che tanta parte hanno nella evoluzione di quel luogo e che hanno un ruolo speciale nell’immaginario locale. L’allestimento è un semplice supporto a questo flusso di persone, racconti, ricordi, che ha iniziato a prendere vita. Si pensa dunque ad una sala per le scuole, in cui iniziare a fare “lezioni di storia viva”, e ad un souvenir shop in cui dare visibilità alla cultura materiale dei nativi, ai loro dolci, ai tessuti, ai deliziosi succhi, ora prodotti “di nicchia” rintracciabili solo nella parte non globalizzata dell’isola. Sono stanze che saranno recuperate ma lasciate pressocchè vuote, predisposte alla flessibilità di attività e mostre che evolveranno nel tempo.
E mentre il progetto di allestimento prosegue con questo approccio, parte intanto il cantiere degli interventi edilizi, che diventa anch’esso, ben presto, un cantiere di socialità, condivisione e inclusione. La gara bandita è internazionale, vince una impresa straniera, ma portare muratori sull’isola è costoso. Vengono assunti ad hoc lavoratori locali con poca o nessuna esperienza, soprattutto di restauro. Ecco allora che il cantiere diventa scuola di formazione, in cui questo manipolo di giovani e meno giovani prima disoccupati impara dagli esperti venuti dall’Italia a staccare l’intonaco senza rovinare la pietra e a stendere il “cocciopesto” a protezione delle murature; impara un lavoro. I rilevatori italiani dotati di laserscanner e drone fanno i loro rilievi alla presenza di ragazzi delle scuole tecniche, i membri del National Trust valutano insieme agli architetti internazionali i colori per le murature più idonei a trasmettere un’idea di luogo anglo-caraibico. I tecnici italiani imparano a pensare “locale”, ad un progetto che possa essere realizzato su un’isola in cui devi importare anche la betoniera, in cui non ci sono laboratori di analisi dei materiali, in cui le maestranze locali, a cui si vuole dare lavoro, hanno competenze ma anche creatività inusuali.
Non è ancora certo che questo percorso andrà a buon fine, ci son stati di mezzo, a minare il regolare svolgimento dei lavori, la fine della pandemia, due uragani, e ora il cambio di Governo. Ma, a ben guardare, non è il taglio del nastro che conta in questa storia di Design for all per la Rigenerazione Urbana, perché in realtà è nel percorso che si sta facendo che stanno nascendo spazi di riscoperta, riappropriazione e inclusione. Certo, se inaugurazione ci sarà, non potrà che essere una grande festa nella parade ground del Forte, accessibile fisicamente e culturalmente a tutti, memore del passato e affacciata sul futuro.
Leggi gli altri articoli della rubrica "Progetto Corale"