Sulla questione casa: verso “nuove matrici trasparenti di convenienza”
La questione della casa è tornata al centro del dibattito, se ne sta occupando l’Europa, se ne stanno occupando diversi paesi europei, se ne accenna anche in Italia. La crisi abitativa è una questione europea. In questo momento sono molti gli studiosi che si sono attivati per riprendere questo grande tema in gran parte dimenticato per tutti gli anni 2000. Nel nostro Paese ad eccezione dello sforzo svolto dal Fondo Investimenti per l’Abitare, mirato all’housing sociale, possiamo dire che non ci sia stata nessuna politica per la casa negli anni 2000. E forse dovremmo risalire addirittura alla prima metà degli anni ’90 quando il problema della casa sembrava risolto. In questa breve nota vorrei provare a mettere sul tavolo alcuni temi che forse possono essere utili alla discussione. L’occasione è stata un interessante recentissimo incontro seminariale dell’IFEL a cui sono stato invitato insieme a vari studiosi e amministratori di comuni italiani.
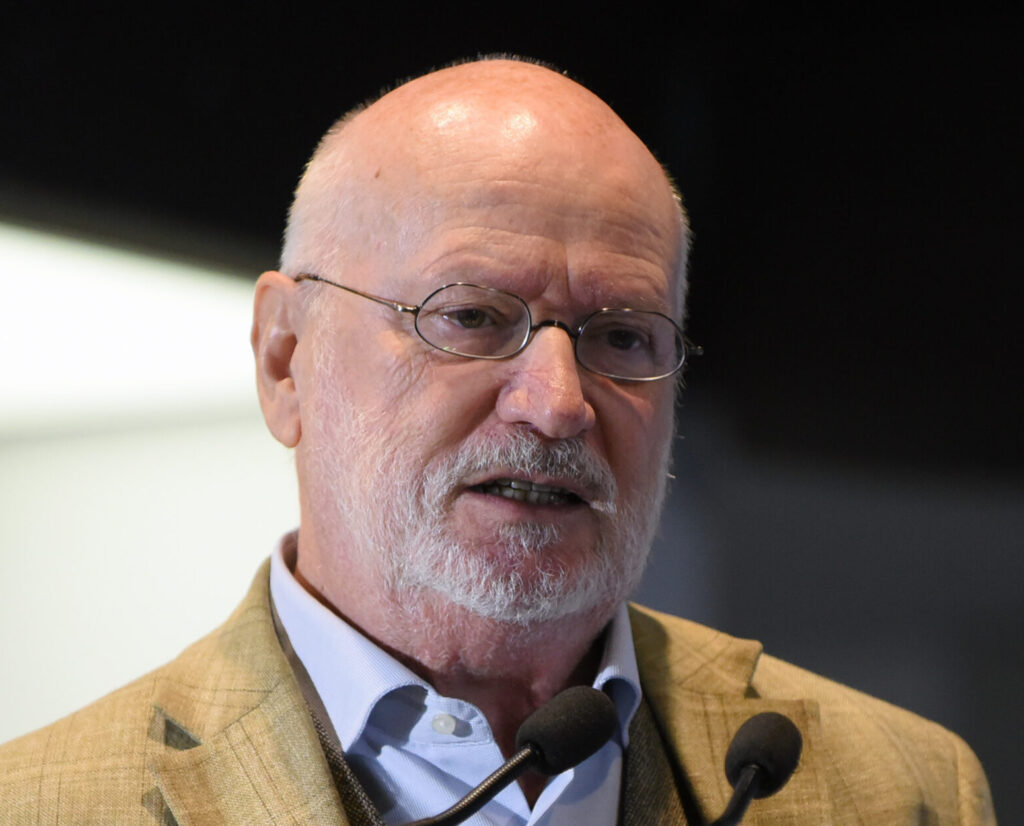
Lorenzo Bellicini, direttore Cresme Ricerche
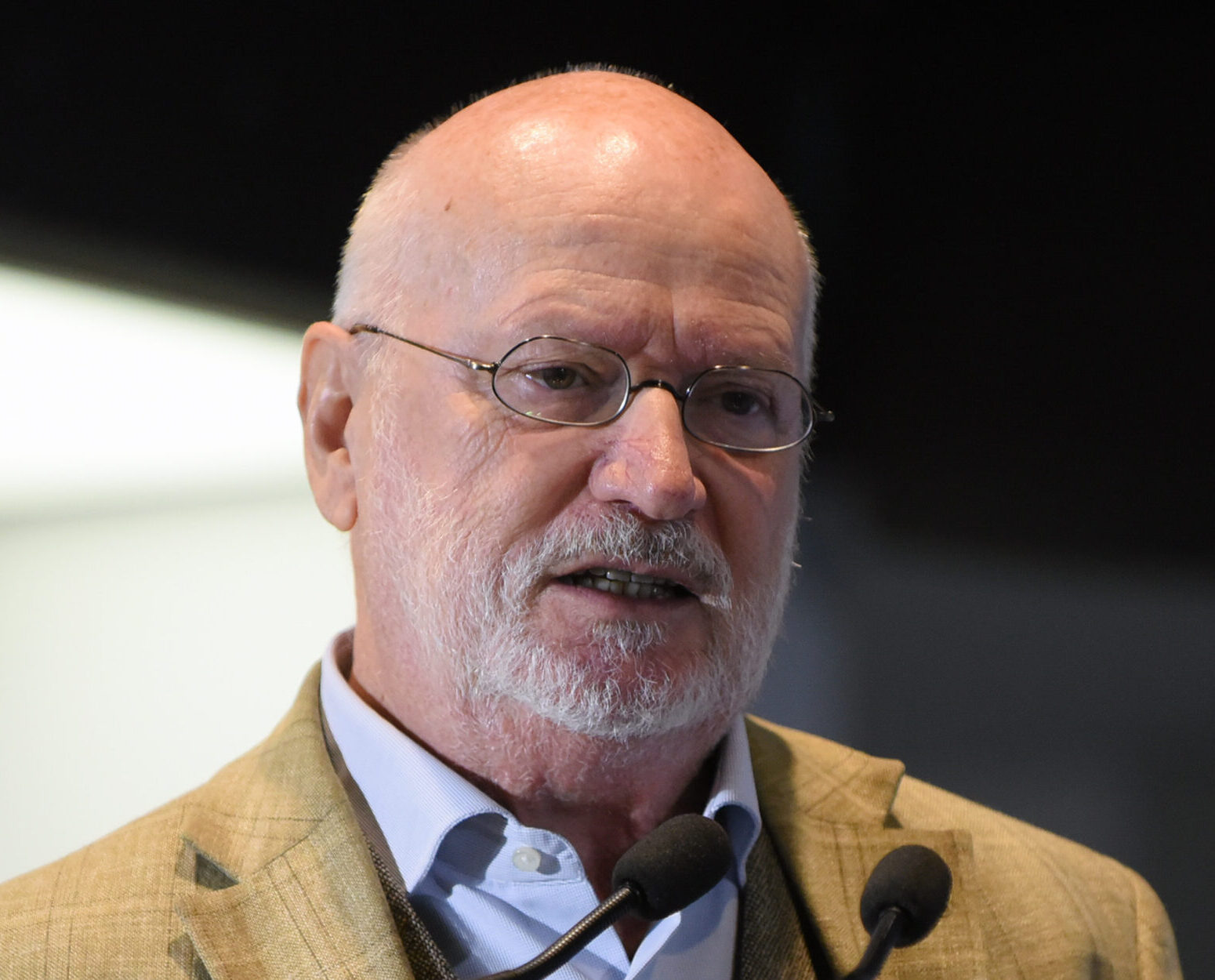
Per prima cosa penso si possa dire che il problema abitativo non sia solo riconducibile al fatto che manchino le case e soprattutto le case in affitto, penso che ci sia un problema più ampio che potremmo definire “costo dell’abitare”. Oltre all’affitto vi sono i costi della luce, del riscaldamento, dell’acqua, del condominio, delle manutenzioni ordinarie. Da questo punto di vista due dinamiche contrarie stanno rendendo la situazione sempre più complessa per un numero di persone sempre più ampio: sono aumentati a causa dell’inflazione i costi di tutto, mentre i redditi non tengono il passo degli aumenti e anzi, unico Paese europeo, a valori deflazionati i redditi degli italiani continuano a perdere capacità di acquisto. Così la platea di famiglie in difficoltà cresce. È così evidente che non serve una “politica della casa da anni ‘80” servono “nuove politiche per la casa” che tengano conto delle diverse tipologie di domanda che determinano la nuova questione abitativa. Anche perché vi sono problemi di risorse. Le condizioni di investimento e i costi dopo la pandemia sono profondamente cambiati.
Ma tornando qui al tema stretto della casa, la prima cosa che dovremmo capire è quante case servono. La stima è alla base delle politiche che si stanno attivando in molti paesi europei (torneremo su questo tema in un prossimo contributo). Nel determinare il fabbisogno, anche con un grado di urgenza, potremmo dire che al primo posto del problema vi è la domanda di Edilizia Residenziale Pubblica. La fascia più delicata della domanda. Nel seminario dell’IFEL il Presidente di Federcasa ha detto che le famiglie che hanno presentato domanda e hanno diritto di accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica sono 250.000. Quindi per rispondere a questa domanda dovremmo trovare 250.000 case. Potremmo costruirle? Facciamo due conti: 250.000 case nuove X 70 mq per casa x 2.000 euro di costo di costruzione (valore indicativo: dipende da cosa si vuole costruire) = 35 miliardi di euro. Solo per l’ERP. In dieci anni sarebbero 3,5 miliardi all’anno; in venti anni 1,75. Di certo date le caratteristiche dell’ERP, le risorse non possono che essere pubbliche. Ci sono queste risorse? È il caso di ripensare alla Gescal?
Ma non servono solo le case ERP. Facciamo un altro rapido conto. Il tema merita ben altre riflessioni. Secondo l’Istat le abitazioni occupate dalle famiglie residenti sono 25,7 milioni, ma le famiglie residenti sono 26,2 milioni: ci sarebbero 500.000 famiglie residenti che vivono in coabitazione (oppure non abitano una abitazione occupata da residenti). Non vale la pena approfondire qui il tema, solo grandezze: con i conti di prima, rispondendo con le nuove costruzioni, servirebbero 70 miliardi di euro: la metà dallo Stato, l’altra metà trovando soluzioni innovative che coinvolgano altri investitori, che però dovrebbero rientrare dell’investimento. Quindi bisognerebbe far bene i conti.
Ma c’è bisogno di costruire nuove case? In Italia, secondo l’Istat, ci sono 35 milioni di abitazioni e 9,5 milioni di case non occupate (se ne è tanto parlato). Attenzione la definizione corretta dell’Istat è: “case non occupate da residenti”. Quindi possono essere vuote oppure occupate da non residenti, nel conto delle 9,5 milioni di case di non residenti vi sono le case vacanza degli italiani e le case nei paesi delle famiglie di origine degli italiani che si sono spostati nelle città, vi sono le 500.000 case vacanza degli affitti brevi turistici, vi sono le case dei city users un po’ più stabili che abitano nelle città dove lavorano ma mantengono le residenze nei paesi di origine, vi sono le case acquistate dagli stranieri, vi sono le case rimaste residenziali ma erose dalle attività non residenziali, vi sono le case abbandonate, in degrado e che richiederebbero importanti investimenti, vi sono le case che per fattori ereditari sono diventate di più proprietari e non si sa nemmeno quali e quanti siano i proprietari (tema non piccolo in alcune realtà del nostro Paese), vi è una quota di patrimonio frizionale che resta fuori dal mercato per l’incontro tra domanda e offerta. Insomma non è facile fare i conti ma certo sulle case non occupate bisogna avere attenzione.
Su questo tema, nel seminario dell’IFEL il comune di Bologna ha sintetizzato una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano e Avanzi che ha indagato le 27.000 abitazioni non occupate dai residenti stimate dall’Istat nel Comune. Il risultato dell’indagine è che le abitazioni realmente non occupate si possono misurare in 13-15.000, in sostanza la metà di quelle stimate dall’Istat. Questo patrimonio non occupato è risultato diffuso sul territorio – ma più presente in un perimetro che potremmo definire semicentrale – ed è soprattutto definito come “vetusto”, vale a dire che si tratta di un patrimonio con la necessità di interventi di manutenzione di qualche peso per essere riutilizzato. In sostanza ci dice che non è un patrimonio pronto per essere immesso tout court sul mercato bisogna riqualificarlo e in modo minuto.
Anche il Cresme ha affrontato il problema nell’ambito di un lavoro svolto per il comune di Piacenza: sulle 10.000 abitazioni stimate non occupate dall’Istat, sono risultate realmente ‘vuote’ – in quanto totalmente non utilizzatrici di elettricità e di acqua – circa 1.000 abitazioni, anche qui diffuse sul territorio e in condizioni di “vetustà”. In sostanza il patrimonio non occupato c’è, ma è molto meno di quello che si pensa e oltre alle difficoltà di rimetterlo in circolazione bisogna fare i conti con i costi di ristrutturazione e con il fatto che sono diffuse e frammentate nel patrimonio esistente.
Vi è poi il grande problema della definizione tipologica della domanda: cosa consideriamo edilizia residenziale pubblica, cosa edilizia residenziale sociale e cosa edilizia di libero mercato. Sempre nel seminario IFEL il presidente di Federcasa ci ha detto che la soglia dei 30.000 euro di reddito netto determina in sintesi il limite massimo per rientrare nella fascia dell’ERP. Nel 2023 l’ISTAT ha stimato che le famiglie residenti in Italia abbiano percepito un reddito netto annuo al netto degli affitti figurativi pari in media a 37.511 euro, ma calcolando il valore mediano, ovvero il livello di reddito che divide il numero di famiglie in due parti uguali, l’Istat ci dice che il 50% delle famiglie residenti in Italia ha un reddito non superiore a 30.039 euro, 2.503 euro al mese (va poi detto che il reddito mediano di questa parte della popolazione nel Mezzogiorno è di 21.628 euro, 1.802 euro al mese).
Il dibattito sull’edilizia sociale ci porta a dire che è edilizia sociale quell’edilizia che consente di pagare un affitto, il solo affitto, a un valore non superiore al 30% del reddito. Se usiamo il parametro dei 37.511 euro del reddito medio si tratta di 11.253 euro= 937 euro al mese; ma per il 50% degli italiani sarebbe 9.012 euro= 750 euro mese.
Ora secondo i dati di “Idealista” il valore medio dell’affitto in Italia è di 14,9 euro/mq/mese ad agosto 2025, per Immobiliare.it e di 14,4 euro: l’affitto per una casa di 70 mq è di 1.028 euro. Nel 2023 era di 790 euro; nel 2018 era di 660. Come si vede la tensione abitativa è crescente ma i valori medi oggi sono particolarmente pesanti. Ma valutare l’affitto medio è un errore, il mercato è troppo differenziato: a Milano ad agosto 2025 l’affitto medio mensile è 22,6 euro/mq; a Roma di 18,3 ma a Rieti è di 5,6 euro, a Reggio Calabria di 5,5 euro. L’affordability va misurata sulla base di tre indicatori: il reddito, i valori di mercato, i costi di costruzione e ristrutturazione. Le condizioni d’offerta di risposta alla domanda, dati i costi di costruzione o ristrutturazione, sono possibili se si fa riferimento all’investimento privato o a quello “paziente” solo in alcune realtà urbane. Altrimenti l’unica risorsa a cui pensare è quella pubblica. Di certo lo è per l’ERP. Ma anche la definizione di housing sociale viene dalle condizioni differenziata territorialmente.
L’unica possibilità che vedo, al di là di numerose e importanti azioni che soprattutto i comuni stanno faticosamente cercando di attivare nei loro territori, molto interessanti ma contenute nei numeri, è puntare, dove è possibile, sulla rigenerazione urbana. Solo così potrebbero essere rese disponibili delle risorse, che il pubblico oggi non ha. Ma per fare questo occorre disegnare quelle che abbiamo chiamato “nuove matrici trasparenti di convenienza”. E si potrebbero anche rilanciare nuovi modelli di incentivi fiscali. In sostanza bisogna imparare a far bene i conti. Nel convegno organizzato da DIAC che si terrà il 9 di ottobre proveremo a dire qualcosa anche sulla base di riflessioni sviluppate nell’ampio studio svolto per Ance Emilia-Romagna sulle nove città capoluogo e sulle direttive date per gli ambiti operativi dalla Regione.

