La questione risorse per la casa: rigenerazione urbana, PPP, incentivi e nuove modalità di fare i conti in trasparenza
Come abbiamo cercato di accennare nel precedente contributo (DIAC 5 Ott 2025, Sulla questione casa: verso “nuove matrici trasparenti di convenienza”) la questione abitativa si scontra con un problema di risorse e tenuta dei conti. Abbiamo visto che solo per affrontare la questione delle famiglie con diritto di una casa di edilizia residenziale pubblica in attesa (250.000 famiglie) servirebbero ca. 35 miliardi di euro solo di costi di costruzione tecnici, e se considerassimo una domanda sociale aggiuntiva di altre 250.000 abitazioni (data dalla differenza tra famiglie residenti e famiglie in abitazioni), servirebbero nel complesso 70.000 miliardi. Ora con l’orizzonte dei conti pubblici appare difficile affrontare il problema. (…)
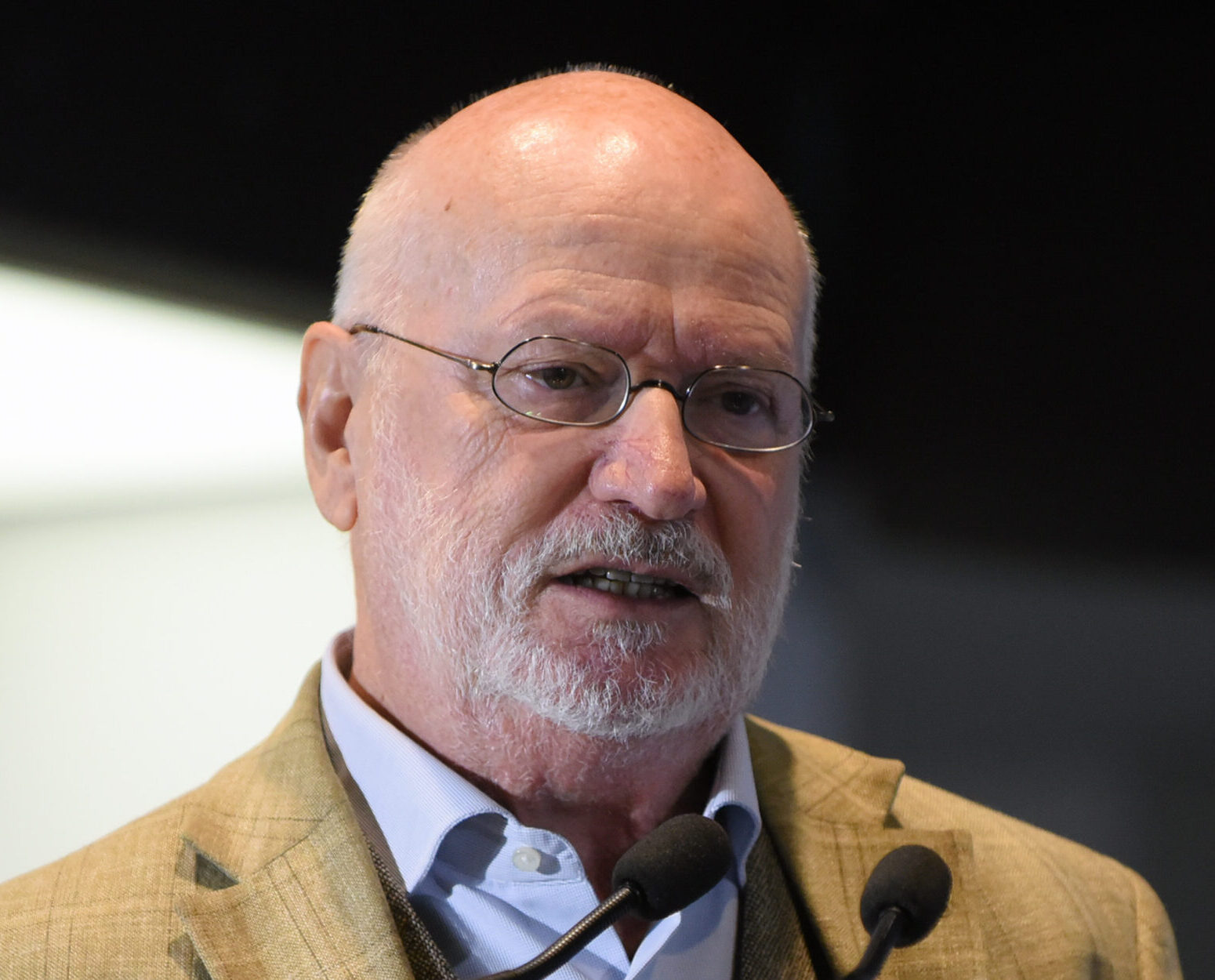
In questo momento tutto il peso della questione abitativa ricade sui comuni Italiani e urbanisticamente sulle Regioni. Per quanto riguarda l’ERP in realtà potremmo dire tout court che non se sta occupando nessuno, perché le risorse necessarie sono così importanti e la domanda così alta che si interviene molto, molto marginalmente. Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Sociale si pensa che questa potrebbe derivare come quota dei progetti di rigenerazione urbana a motore privato. Ad esempio la Regione Emilia Romagna, che si è mossa prima di altri, ha deciso che “il fabbisogno di ERS, in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa, debba essere soddisfatto per almeno il 20% dalle nuove previsioni di edilizia residenziale”. In sostanza a carico dello sviluppo privato. E dato che il consumo di suolo tende a zero, questo dovrà avvenire all’interno degli interventi di rigenerazione urbana. Ci si è così resi conto che è assolutamente necessario lavorare attraverso la costruzione di Accordi Operativi, ai quali compete il ruolo di tradurre le linee di azione dei PUG, “in progetti concreti: definiti nella loro conformazione fisica e fattibili nella loro costruzione tecnico-finanziaria». La costruzione tecnico-finanziaria si traduce nella capacità da parte delle amministrazioni di dialogare sul piano delle tecnicalità dei “quadri tecnico economici” che stanno alla base di un investimento. Per questo la Regione ha avviato un innovativo percorso formativo per tecnici comunali e operatori privati.
Le condizioni di partenza di questi conti però sono oggi diventate molto diverse da quelle del periodo pre-pandemico, per tre ordini di motivi: la deriva inflazionistica ha portato i costi di costruzione a crescere quanto meno del 35%40%50% rispetto al 2019; i valori di mercato, in particolare, quelli degli affitti sono cresciuti ancor di più; si sono poi fortemente accentuate le differenze nel valore di mercato delle case nelle diverse città e parti di città; e soprattutto i redditi delle famiglie deboli e medie non hanno tenuto il passo con l’inflazione, facendo sì che la determinazione delle condizioni che fissano i parametri dell’edilizia sociale divenissero più difficili da comporre. Per farla breve, la crescita dei costi di costruzione e gli ulteriori elementi che determinano un “quadro tecnico economico”, dal costo dell’area e dell’immobile dismesso, della bonifica nel caso, degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, più i costi della progettazione, e quelli vari di intermediazione oltre ai costi finanziari e alla valutazione del rendimento di impresa, oltre alla condizioni tecnico-urbanistiche (si pensi agli standard o ai limiti degli interventi) determinano condizioni della produzione su valori tali da rendere difficile il far tornare i conti. Anche per quel tipo di investimento paziente venuto dai fondi. Tanto da dover dire che l’edilizia sociale oggi si può fare sono in poche realtà o parti urbane dove i conti possono tornare e con condizioni che rendono difficile parlare di edilizia sociale visti i redditi.
Va inoltre fatta un’altra considerazione una percentuale come quella del 20%, a titolo indicativo, presuppone una produzione privata pari a 100, il che vuol dire che se programmo di realizzare 7.500 abitazioni di edilizia sociale come quota della produzione privata, come è previsto per Bologna nei prossimi dieci anni, dovrò prevedere la realizzazione di 37.500 nuove abitazioni: che potremmo tradurre in 75.000 nuovi abitanti, poco meno del 20% in più della popolazione di Bologna attuale. Un importante programma di sviluppo e ben superiore alla capacità produttiva attuale.
È evidente che dati i numeri in gioco la strada è per forza di cose, in quasi tutte le realtà del Paese, un’altra. Vanno costruiti altri modelli e vanno portati in gioco altri strumenti. Una parte della risposta può venire dal miglior uso del patrimonio esistente, ma abbiamo visto che i margini sono contenuti, quanto meno anche qui servirebbero risorse, dato che reimmettere sul mercato patrimonio non occupato e quasi sempre “vetusto” comunque richiede risorse.
Forse a questo punto potrebbe essere importante cogliere la spinta che viene dall’Europa per pensare a qualcosa di nuovo, a nuovi strumenti e a nuove risorse: pensiamo che si debbano mettere in gioco, risorse private, risorse europee e incentivi fiscali. È un tema sul quale il CRESME ha riflettuto in passato (si veda lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera Dei Deputati – Dipartimento Ambiente, Le politiche di rigenerazione urbana, prospettive e possibili impatti, N. 32/2 – Giugno 2022 ) ma sul quale, per altri versi si era espresso anche l’INU, con una proposta che utilizzasse la “fiscalità urbana” all’interno di strumenti urbanistici di nuova concezione denominati “programmi integrati di area” che definivano ambiti urbani nei quali intervenire per raggiungere obbiettivi di riqualificazione energetica, sociale, ambientale. Lo strumento era pensato dall’INU per il PNRR, ma potrebbe essere utile pensando ai nuovi fondi strutturali europei che dovrebbero arrivare sul tema casa. L’INU definiva un “pacchetto di incentivazioni fiscali” che comprendeva: “esenzione dall’IMU; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti funzionali alla effettuazione degli interventi; proroga della applicazione dei benefici in materia di risparmio energetico e manutenzione straordinaria stabiliti dalle norme vigenti; esenzione dai tributi per l’occupazione di suolo pubblico e dalla tassa dei rifiuti nel periodo di esecuzione dei lavori; esenzione dalla corresponsione del contributo sul costo di costruzione; deduzione dal reddito delle persone fisiche di quota parte dell’IVA in relazione all’acquisto dalle imprese di unità residenziali costituenti “prima casa”; esenzione dai tributi per l’occupazione di suolo pubblico per gli immobili ad uso commerciale dopo l’esecuzione degli interventi fino alla scadenza del Programma; deduzione dal reddito del locatore delle spese ordinarie di gestione degli immobili dati in locazione; esenzione dall’imposta di registro annuale per gli immobili dati in locazione”.
La proposta del CRESME partiva dalle risorse, da un lato dai Fondi di coesione e dai Fondi strutturali europei; dall’altro dagli investimenti incentivati dei privati utilizzati per la riqualificazione delle proprie abitazioni; dall’altro ancora dai possibili interventi di operatori privati nel campo della rigenerazione urbana da portare a sistema. Alla base vi era la possibilità di attivare degli “interventi territoriali integrati” in aree urbane ampie, cosi come nel Regolamento dei Fondi Strutturali era in prevalenza previsto per ambiti non urbani, facendo ricorso al Partenariato Pubblico e Privato. Quindi un nuovo strumento che individuasse delle aree urbane rispetto alle quali attuare interventi di riqualificazione sociale e energetica.
Va ricorda che per quanto riguarda i Fondi Europei è importante considerare il fatto che questi devono essere attivati attraverso il cofinanziamento del Paese destinatario, vale a dire che se l’Europa per il settennato 2021-2027 ha attribuito all’Italia 40 di miliardi di euro, per attivarli l’Italia dovrebbe investire ca. altri 40 miliardi di euro (un po’ meno). In sostanza sono risorse che devono essere trovate. Ora è molto probabile che i nuovi fondi europei guardino alla casa sostenibile come obiettivo e lì dovranno essere indirizzati. Di certo permane il problema dell’efficientamento energetico come primario obiettivo europeo.
Per quanto riguarda gli interventi minuti di riqualificazione dei privati, prima del boom dei superbonus, si trattava di investimenti che annualmente si aggiravano sui 28 miliardi di euro all’anno, dei quali il 50% (un po’ meno) messo dai privati. Quindi 14 miliardi di euro all’anno. Certo oggi di incentivi non si può parlare, ma forse potremmo usarli meglio se pensassimo che si trattasse di operazioni di partenariato pubblico e privati diffuso da poter “riutilizzare”. E in ogni caso vi saranno incentivi del 36% per le prime case e del 30% per le seconde. (Un po’ poco per evitare il sommerso).
In sostanza in quelli che potremmo chiamare “Piani di Rinascimento urbano e accesso alla casa sostenibile e energeticamente efficiente in Partenariato pubblico e privato”, si potrebbe attivare un percorso in grado di valorizzare un importante insieme di risorse esistenti mirandole, almeno in parte, verso le aree urbane a maggiore criticità abitativa e sociale, ottenendo anche delle ottimizzazioni non di poco conto sull’uso delle risorse stesse.
Infatti le risorse europee dei fondi strutturali finalizzate alla casa potrebbero contribuire a rendere possibile l’edilizia residenziale pubblica in forma diretta e l’edilizia sociale in termini di contributo nell’ambito degli interventi di PPP di maggiore dimensione; mentre l’insieme degli investimenti di riqualificazione edilizia e energetica incentivati potrebbero essere portati come interventi per la riqualificazione energetica che sono parte degli obbiettivi più ampi di riqualificazione del Piano e rendicontati come contributo privato e pubblico. (Pagando con i bonifici bancari le imprese è tutto rendicontabile). In questo modo, queste risorse potrebbero essere rendicontate come co-finanziamento dei fondi europei, e quindi “utilizzate doppiamente”. Il 9 ottobre presenteremo un po’ meglio questa ipotesi, nel convegno organizzato dal DIAC nell’ambito della tre giorni promossa dall’Ance e dedicata alla “Città nel futuro 2030–2050”.

