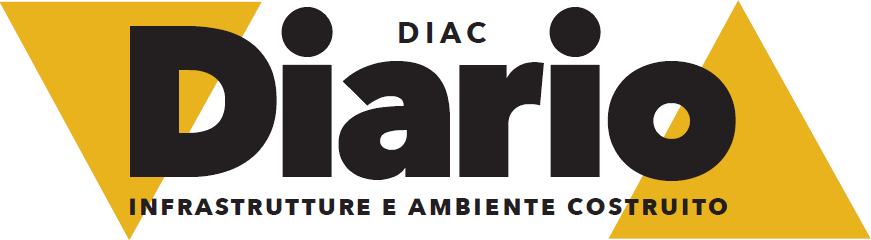DIARIO POLITICO
Meloni rinuncia alla trasferta all’estero e si blinda a Roma con le tensioni su candidature regionali e legge di bilancio dalle casse vuote
La politica internazionale continua a dettare l’agenda di Giorgia Meloni. La premier ha cancellato all’ultimo momento il viaggio nell’Indopacifico programmato a fine agosto per partecipare ai vertici sulla guerra in Ucraina: decisione solenne, certo, ma con un effetto collaterale inevitabile. Restando a Roma, i riflettori tornano infatti a illuminare anche le spine di casa: una legge di Bilancio con le casse vuote e gli alleati pronti a scannarsi su tagli fiscali e rottamazioni mentre la telenovela sul nodo candidature regionali, a partire dal Veneto, resta ancora irrisolto.
A tre settimane dalla gara che si aprirà il 28 nelle Marche la premier e i suoi due vice di Fi e Lega – Tajani e Salvini – non sono ancora riusciti a raggiungere un accordo oltre che sul dopo Zaia anche in Puglia e Campania dove il campo largo guidato dal duo Schlein-Conte ha ufficializzato i nomi dell’ex sindaco di Bari Antonio Decaro e dell’ex presidente della Camera M5s Roberto Fico.
Probabile che Meloni e i suoi alleati volessero attendere le scelte degli avversari prima di decidere. Anche perché tanto l’investitura di Decaro che quella di Fico hanno prodotto più di qualche malumore tra i governatori uscenti: Michele Emiliano, che sognava di restare in panchina come “saggio consigliere”, e Vincenzo De Luca che continua a mandare messaggi non proprio pacifici all’indirizzo del suo partito. Il tempo delle scelte però non può essere più rinviato. Anche perché questo test elettorale d’autunno verrà letto – come sempre avviene – anche in chiave nazionale. E non solo perché sono coinvolti oltre 17 milioni di elettori di Veneto, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta. Per la prima volta ci sarà un’alleanza tra i principali partiti di opposizione – Pd e M5s – in tutte le Regioni chiamate al voto. Una prova generale in vista delle politiche del 2027 che Meloni osserva non senza apprensione.
Non a caso si è tornati a parlare di riforma elettorale. A spingere in questa direzione è soprattutto la maggioranza e in particolare il partito di Meloni, Fdi, che vuole abolire i collegi uninominali, passando quindi a un proporzionale con premio di maggioranza e con l’indicazione del premier sulla scheda. Nel 2022 la vittoria di Meloni e del centrodestra è stata anche il frutto delle divisioni dell’opposizione: il Pd da una parte, M5s dall’altra e i renziani in una terza. Ma se tra due anni queste forze si presentassero unite la vittoria del centrodestra nei collegi, soprattutto al Sud, sarebbe tutt’altro che scontata. Abolirli certamente renderebbe il bis di Meloni molto più facile. Il gradimento nei confronti della premier continua ad essere alto.
Meloni però vuole minimizzare i rischi. Anche perché sono molte le variabili che non può controllare e potrebbero rivelarsi determinanti per il proseguo della luna di miele tra la premier e i suoi elettori. A partire dalle crisi internazionali e dalle loro ricadute interne: dal prezzo dell’energia alla riduzione dell’export con una domanda interna che continua ad essere asfittica. L’uscita dalla procedura d’infrazione e la discesa dello spread sono certo segnali postivi per la presidente del consiglio che tuttavia non hanno un riflesso immediato nelle tasche degli italiani. Le risorse a disposizione per la prossima manovra anche quest’anno saranno poche. La crescita è quasi ferma e l’Italia – nonostante i progressi – resta il Paese con il maggior debito.
La legge di Bilancio per il 2026 si annuncia anche stavolta come una prova di equilibrismo. Solo il taglio dell’aliquota Irpef per il ceto medio (dal 35 al 33%) costa almeno 4 miliardi e altrettanti ne servirebbero per finanziare la nuova rottamazione cara al segretario della Lega che rilancia pure sull’estensione della flat tax. Del resto Salvini già alle prese con il caso Zaia ( la rinuncia della Lega alla guida del Veneto o domani della Lombardia) ha bisogno di massimizzare il consenso per evitare il processo interno. I leghisti del Ponte sullo Stretto non sanno che farsene tanto più dopo il “No” dell’amico americano a inserirlo tra gli investimenti da includere nel 5% di spese per la difesa che potenzialmente sono finanziabili anche in deficit.