Fondamentale alla Biennale
Lovera (Formedil): la scommessa della formazione per affrontare la rivoluzione dell’Ia nei cantieri
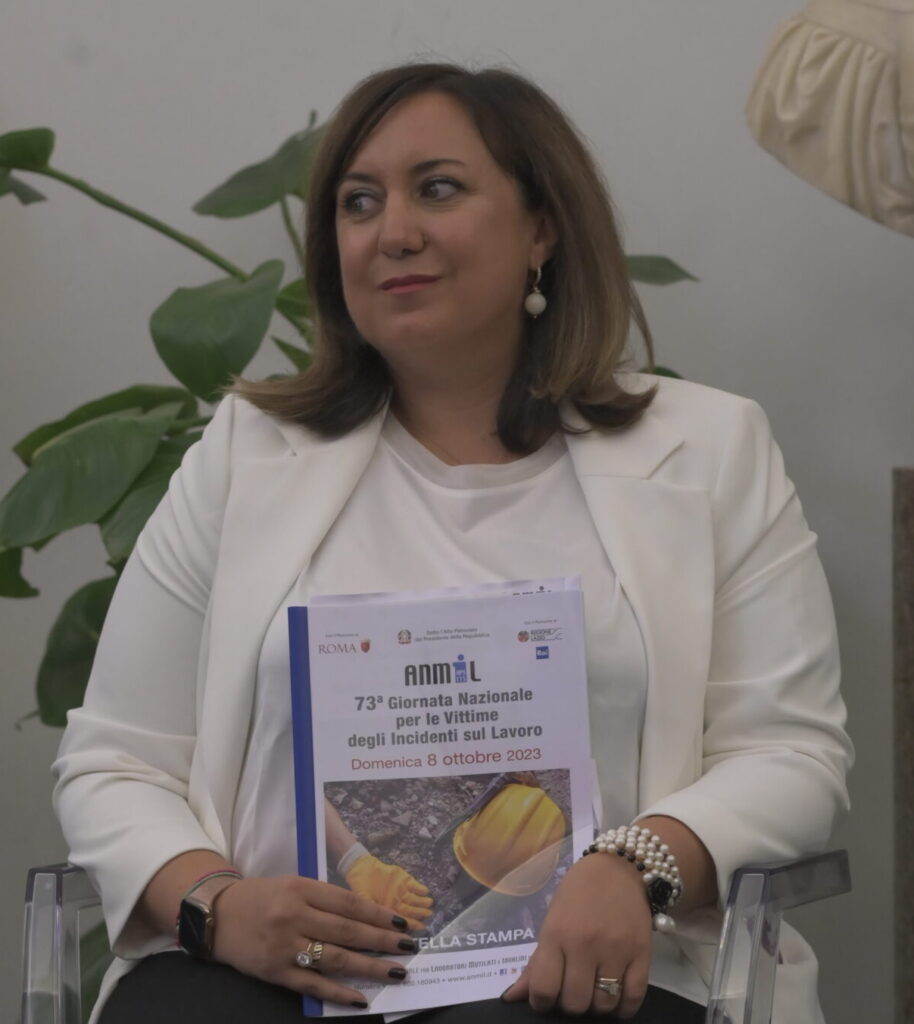
L’imperativo è quello di non subire il cambiamento ma governarlo ed esserne protagonisti. E’ un cammino denso di insidie e di rischi quella aperto dalla rivoluzione digitale e dall’intelligenza artificiale che, con la sua portata poderosa e la sua velocità travolgente, impone sfide dirompenti. A questo non si sfugge: è un cammino obbligato perché è questo che ha aperto le porte al futuro con tutte le sue opportunità. E’ un cammino obbligato anche per il settore delle costruzioni dove l’innovazione tecnologica riveste un ruolo chiave, dalla progettazione alla realizzazione, conferendo una nuova complessità all’‘ecosistema cantiere’. L’Ia offre nuovi strumenti e soluzioni per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità con progetti intelligenti ma pone anche sfide etiche che richiedono un approccio responsabile e in questo contesto la formazione è una leva cruciale. È questa complessità nelle sue numerose angolature e sfaccettature che è stata al centro della riflessione alla Biennale di Architettura di Venezia, venerdì scorso, nel primo appuntamento del ciclo di incontri nell’ambito di Construction Futures Research Lab, progetto speciale della 19. Mostra Internazionale di Architettura promosso da Ance insieme alla Filiera Fondamentale. Una complessità che il dibattito dal titolo “Artificiale Collettivo”, moderato da Sebastiano Maffettone (LUISS Business School), ha affrontato con un approccio multidisciplinare, con interventi di studiosi e professionisti esperti.
Quella dell’intelligenza artificiale “è la più grande rivoluzione culturale e antropologica che l’uomo ha incontrato, dopo l’invenzione della scrittura. Non bisogna averne paura ma è inevitabile”, ha affermato Mario Rassetti, professore emerito di Fisica teoretica al politecnico di Torino. “L’intelligenza artificiale non è ancora una scienza, ma una sofisticata pratica che ci permette di fare un passaggio, aiuta a fare meglio cose che si fanno con la testa. L’Ia è soprattutto una forza bruta , un sistema di software molto raffinato, basato su tanta forza bruta e capacità di calcolo, che ci permette di riprodurre cose che l’uomo fa con la sua mente”. Basti pensare che nel 2024 sono stati prodotti 500 zbyte di dati, dove zeta sta per mille miliardi di miliardi di byte. La sua sfida più grande è quella di riprodurre il cervello umano “ma non riusciremo mai a farlo perché il cervello è la più straordinaria macchina che esiste, di mostruosa complessità”. Ma , soprattutto, c’è un punto dove l’intelligenza artificiale non potrà arrivare: quello di avere “ l’autocoscienza attraverso la quale sappiamo di esistere”. Piuttosto, questa evoluzione dota l’homo sapiens sapiens, attraverso quelle protesi che sono i cellulari, di una connettività che nessuna creatura ha mai avuto. “Quella macchina sta cambiano la scala dei valori. Possiamo pensare alla superficie del pianeta come a un’enorme corteccia cerebrale dove gli uomini sono i neuroni e le sinapsi sono le connessioni, stiamo costruendo un cervello planetario con intelligenza collettiva”, ha prospettato Rassetti. Diventa ancora più pressante la necessità di impegnarci per governarla efficacemente a nostro favore.
Di questa rivoluzione colpisce la velocità. “Se le automobili hanno impiegato 60 anni per raggiungere 50 milioni dii utenti, i social hanno raggiunto gli stessi numeri in pochi giorni “, ha fatto osservare Giuseppe Italiano, docente di Computer Science alla Luiss. “Da una società basata sul petrolio con grandi aziende come Shell e Chevron che erano le più ricche, in 10 anni c’è stata una rivoluzione epocale che ha portato Apple, Google, Microsoft ad essere le aziende più ricche. Parliamo di trilioni di dollari di valore di capitalizzazione che corrispondono al pil di economie avanzate. Nvidia ha il PIl della Francia, Google della Italia”. Non è solo una questione di velocità. C’è di più: “abbiamo aziende con un potere immenso ma che non hanno sottoscritto alcun contratto sociale. Non era mai successo nella storia”, ha detto Italiano. Se la rivoluzione che si è verificata con il passaggio dal nomadismo all’agricoltura, ha cambiato la catena del cibo; se la rivoluzione industriale ha cambiato la catena dell’energia, ora la rivoluzione digitale cambia la catena dell’informazione. “Bisogna avere idea di cosa c’è dietro, serve spirito critico, ci sarà un impatto nelle vite umane”.
Spirito critico e pensiero critico non possono e non devono arretrare davanti al cambio di prospettiva determinato dall’avvento delle nuove tecnologie. Anzi, proprio perché “le tecnologie sono in mano di pochissime persone che con noi non hanno un contratto sociale, bisogna conoscerne i rischi fino in fondo”: è la sollecitazione arrivata dalla filosofa è fondatrice di Tlon, Maura Gancitano. Nel Fedro, Platone definiva il “pharmakon” medicina ma anche veleno, quindi un rimedio ma al tempo stesso una sostanza pericolosa. Il filosofo greco usa questo termine per descrivere la scrittura, sottolineando la sua potenzialità di essere un mezzo per la conoscenza, ma anche per la perdita della memoria e della vera comprensione. Delle nuove tecnologie dobbiamo conoscere a fondo i rischi. Come nel pharmakon “dobbiamo capire dove è la cura e capire dove è il veleno”. “Dobbiamo porci la stessa domanda di Platone, ha concluso Gancitano.
il dibattito della giornata in Biennale è stato poi arricchito dagli interventi di Antonello Marotta (Progettazione, Università dISassari), che ha descritto come le cattedrali e altre opere di architettura possono essere esempio di intelligenza collettiva e di interazione tra uomo e natura, e con Donato A. Grasso (Zoologia, Università di Parma) che ha raccontato il modello di società organizzata delle formiche, insetti sociali che di fatto utilizzano un sistema di intelligenza collettiva nelle interazioni e nella suddivisione del lavoro.
Un lungo percorso, tra scienza e filosofia, che porta al mondo delle imprese. A trarre le conclusioni sono stati Luigi Serio, docente di Economia delle imprese, Università di Milano, e la presidente Formedil Elena Lovera. Serio si occupa di portare l’innovazione all’interno delle aziende e ha spiegato come viene percepita l’intelligenza artificiale a livello sia individuale che organizzativo, mettendo in guardia dal rischio dell’unlearning, del disapprendimento. “È un tema pericolosissimo quando nelle aziende si dice ‘abbiamo sempre fatto così’. C’è una transizione digitale per tutti , ognuno può trovare il proprio spazio.”. E c’è la realtà del cantiere che “ha dentro tutto: l’esperto , l’anziano, il giovane, l ‘immigrato; ha il mix generazionale e il mix culturale”. La presidente Lovera, parlando a nome di Fondamentale, ha sottolineato la grande scommessa di tutta la filiera unita rispetto alle innovazioni tecnologiche. “Oggi è il nostro primo passo, ma il percorso va avanti. Il progetto che ci vede qui in Biennale, con lo studio sulle applicazioni dei robot umanoidi, ha l’obiettivo di migliorare il lavoro nelle costruzioni. I robot non sostituiranno gli uomini, ma li aiuteranno nelle situazioni più critiche e complesse. E questo affinchè il cantiere sia sempre più sicuro, di qualità e inclusivo di competenze e saperi trasversali”.
“Siamo darwiniani – ha detto la presidente – convinti che la strada migliore per resistere è quella di adattarsi al cambiamento”. È la presenza in Biennale si spiega con l’esigenza di “cercare una serie di voci per darci degli stimoli per vedere come nel nostro mondo possiamo adattarci al cambiamento”. Per Lovera, “ la formazione dovrà andare in una direzione che oggi non c’è ancora, una formazione differente da quella che facciamo oggi. Dobbiamo tener conto dell’inclusività dove l’intelligenza artificiale non riguarda solo i progettisti ma anche gli operatori edili. È un paradigma nuovo che dobbiamo fare per ragioni di sicurezza sul lavoro e non solo predittive. Occorre fare presto”.

