LA POLITICA DEL MARE
Il dilemma irrisolto fra porto-impresa e porto-Pa e la necessità di una rete FEDERALE europea gestita dalla Ue
L’amministrazione pubblica della mobilità nel comparto delle merci impone una serie di scelte – probabilmente di livello europeo – urgenti e non rinviabili
27 giugno
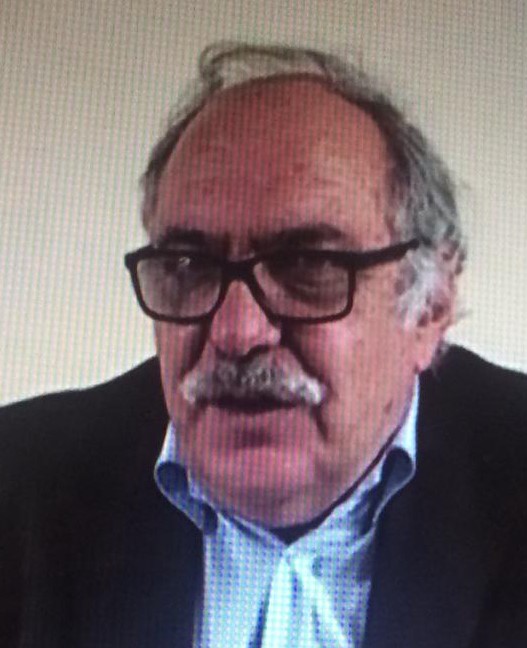
IN SINTESI
Solo una di queste scelte, non la più importante, riguarda l’amministrazione delle infrastrutture portuali. Quelle ineludibili sono, anzitutto la promozione di un comparto marittimo/ferroviario in grado di reggere, in una prospettiva pluriennale, la congiuntura della comunità internazionale. È evidente, infatti, che il trasporto marittimo merci in Italia è influenzato dalle politiche delle principali compagnie marittime e ferroviarie.
In secondo luogo, la stessa congiuntura internazionale mette in dubbio il principio fondante la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare e cioè il principio di libertà della navigazione persino negli stretti e nel mare territoriale. Una politica nazionale che promuova questa libertà, malgrado la spinta che proviene dalle grandi potenze, è decisiva per il Mediterraneo e per la logistica italiana.
Prima parte: la regolazione dei porti
Iniziamo dalia regolazione dei porti e delle infrastrutture connesse. La riforma della legge 84 di cui al Dlgs 169/2016 non ha cambiato la fisionomia della portualità italiana. La diversità di opinioni nel 2016 fra Palazzo Chigi e il Partito democratico – e cioè fra una lettura impostata su poche autorità pubbliche ben coordinate dal centro, così da rafforzare una politica comune della mobilità (che traeva ispirazione dalla pianificazione europea di cui al regolamento 2013/1315) da un lato e una lettura impostata su una pluralità di autorità/imprese in concorrenza fra loro dall’altro – non ha portato a nulla di buono. Alcuni momenti significativi hanno connotato questo scorcio di tempo.
Il contenzioso europeo
La vicenda del Dlgs 169 non ha certo evitato, anzitutto, l’imbarazzante contenzioso con la commissione europea (che peraltro il ministro Delrio e la vicepresidente Vestager hanno cercato di evitare con il loro incontro del 5 luglio 2017), concluso con la decisione della Corte europea T-166/21 del 23 dicembre 2023 che ha dichiarato le Autorità portuali vere e proprie imprese ex art. 101, Tfue. Le conseguenze di questa lettura dell’art.101, Tfue, che sarebbe stato bene evitare, possono essere pericolose se la natura di impresa dell’Autorità dovesse essere rilevata dalla commissione in contesti diversi dalla fiscalità. Inoltre, desta perplessità la scelta del governo, per correre ai ripari, e su suggerimento della commissione, di attribuire rilevanti compiti all’Autorità dei trasporti per quanto attiene alle concessioni demaniali portuali.
Il controllo del centro: fra luci e ombre
La scelta di assoggettare le Autorità portuali alla direzione del governo centrale, molto criticata ad esempio da Giuliano Gallanti e Beppe Pericu, non è stata peraltro seguita da alcuna misura di attuazione che consentisse al Ministero competente un esercizio di politica industriale da realizzare anche attraverso gli “indirizzi” previsti nel Dlgs 169. Eppure, a seguito della scelta di centralizzare la politica portuale, ci si sarebbe attesi un ente centrale competente e autorevole in grado di sviluppare sia politiche economiche allocative con le principali imprese di traffici di lungo periodo sia scelte coerenti sulle infrastrutture. Si aggiunga che i vertici designati nei porti più importanti sono stati piuttosto espressione della politica locale: come le recenti vicende dimostrano spesso senza possedere le caratteristiche di comprovata professionalità previste all’art.8 della legge 84.
La vera natura delle Autorità portuali: Pa o imprese?
Non si è fatta chiarezza sulla funzione dell’Autorità portuale: se la maggior parte dei presidenti nominati nel 2017, in quanto preposti alla gestione e regolazione di infrastrutture pubbliche, e non all’esercizio di una attività di impresa, sono stati scelti fra burocrati pubblici, militari della guardia costiera, professori o politici, in altri casi si sono scelti veri e propri manager d’impresa che hanno cosi gestito un ente pubblico non economico non molto diversamente da imprese terminalistiche (magari titolari di diritti speciali), addirittura entrando in competizione con le imprese del settore. Insomma, si è continuato ad oscillare fra l’idea del porto–impresa pre legge 84, che si avvale di varie subsidiaries e contende il mercato (modello Trieste) e l’idea del porto-pubblica amministrazione il cui principale obiettivo è la regolazione e il buon funzionamento del mercato e la promozione dei principi di accesso e di concorrenza che avevano occasionato, dopo la sentenza porto di Genova del 1991 (C.-179/90), la legge 84. E la sensazione è che ai più l’indicata differenza non sia ancora chiara.
L’incertezza sulle regole
Le vicende di questi ultimi mesi provano come questa riforma non abbia affatto incentivato la trasparenza imposta dall’ordinamento europeo nel caso della scelta del contraente della pubblica amministrazione incaricato della prestazione di servizi di interesse generale. Questa esigenza di gestione trasparente delle pubbliche infrastrutture, stretta fra il consociativismo di Genova e la vocazione industriale di Trieste, non costituisce la priorità del mondo portuale se si considerano operazioni ricorrenti come l’estensione della durata delle concessioni o l’ampliamento dell’area assentita in concessione ad aree contigue in virtù di gare molto “teoriche”. Mentre è noto che per il diritto europeo sia l’estensione temporale sia l’ampliamento dell’area in concessione possono essere disposte, anche senza gara, purché si tratti di Servizi di Interesse Economico Generale (Sieg) ex art. 106, Tfue (Altmark, C- 280/00).
La prospettiva nazionale
Oggi si ipotizza una ulteriore riforma della 84 tutta di là da venire. Pare certo sia intesa a rafforzare la governance centrale dei porti principali limitando, quindi, il ruolo delle autorità portuali alla attuazione di scelte di politica economica del Governo. Se il coordinamento fosse svolto da una società per azioni sarebbe molto logico che le autorità portuali fossero a loro volta delle società partecipate dal centro magari con una presenza in minoranza delle regioni e dei comuni interessati. Se invece si mantenesse il modello pubblicistico esistente il controllo del centro dovrebbe essere posto in essere da un dipartimento del Ministero molto cambiato o, meglio, da un ente assimilato all’Enac. Ovviamente una scelta da compiere d’intesa con la DG concorrenza, trattandosi di servizi di interesse generale.
Seconda parte: una politica europea della mobilità
Per chi si occupa seriamente di questa materia il tema si profila, tuttavia, in Europa molto diverso. Infatti, come si osservava, il futuro del trasporto marittimo merci non si esaurisce nel regime dei porti essendo inevitabilmente condizionato da ben diverse tematiche.
La congiuntura della comunità internazionale erede (od orfana?) di Bretton Woods, priva di regole e in mano a Cina e Stati Uniti, impone scelte strategiche che la recente timida modifica del regolamento 1315 non affronta. La nuova Europa dovrà, insomma, chiarire se gli Stati membri, oltre a dare luogo a uno Spazio Europeo dell’Industria, sono pronti a realizzare una politica comune della mobilità che vada al di là della semplice programmazione delle infrastrutture (peraltro tradizionalmente disattesa in Italia).
Una rete federale europea realizzata e gestita dall’Unione
Il primo elemento di questa politica sarebbe una rete federale europea sottratta alla jurisdiction degli Stati nazionali che includa almeno le infrastrutture ferroviarie e portuali essenziali e che sia realizzata e gestita dalla Commissione europea o da una agenzia ad hoc. Ovviamente dovrà trattarsi di una rete davvero minima che colleghi i punti terminali della logistica europea senza quindi riprendere la pianificazione europea che aveva altre funzioni. Necessario pare questo passaggio per consentire ai vari Stati membri di costruire una loro pianificazione nazionale che completi quella europea conferendo certezza al sistema nel suo complesso.
Champions europei a 10/15 anni
Solo l’Unione e/o i Paesi principali possono parallelamente attuare politiche espansive promuovendo Champions europei in grado di contendere il mercato del trasporto marittimo oggi dominato da alcuni players che giocano un ruolo decisivo. Non vi è dubbio che Stati membri e Unione debbano con questi pjayers costruire in modo trasparente una politica futura che assicuri competitività alle imprese europee.
La libertà dei mari: il transito nel Mar Rosso
Pare essenziale ed urgente il presidio della libertà dei mari, come prevista dalla Unclos, per il Mar Rosso da cui dipende in larga misura il funzionamento dei corridoi di traffico Europa-Mediterraneo. Con la consapevolezza che le grandi potenze si orientano piutt.osto verso una visione opposta che nega la libertà (in funzione del Medio Oriente e in Africa). Un tema europeo di assoluto interesse per i Paesi del sud del Mediterraneo che, tuttavia, sembra reagiscano, per ora, in modo molto incerto e senza un’intesa oppure per perseguire obiettivi nazionali (è il caso della Spagna che si candida a servire il continente europeo attraverso i porti di Algeciras e Malaga, sulla rotta delle navi che compiono il periplo dell’Africa, via Francia e Svizzera)

