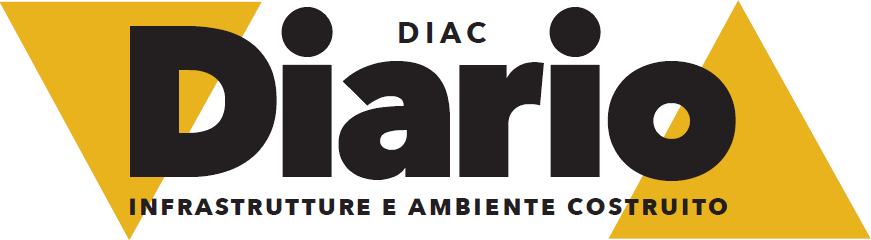“Se fai del bene, fallo bene”: si dice a Rabat, ora anche a Brescia
Mi sono formato e sono diventato operaio metalmeccanico, in una città di fabbriche.
Eravamo talmente tanti noi operai che ci muovevamo come formiche, ogni mattina. Anche quando alcune fabbriche hanno chiuso, ce n’era un’altra che ci faceva lavorare.
Il lavoro negli anni è cambiato siamo passati dal lavorare concimi e pesticidi altamente inquinanti a produzioni diverse, i prodotti che chiamano made in Italy, questo ha di certo cambiato la vita di Brescia e pure la mia.
Io ho vissuto e vivo nella zona di via Milano, un quartiere di operai, di gente che veniva dal sud Italia prima, e poi da tutto il mondo. Tutti, come me, qui per lavorare.
Via Milano negli anni è diventata la mia casa, la mia famiglia. E come in ogni famiglia, le voci a volte si sovrappongono, altre si scontrano, altre si fondono, ma in quel trambusto ti va sempre di restare. Dicevano che fosse la parte più brutta della città, quella più disperata, inquinata, umiliata. Vero da una parte, ma dall’altra era casa nostra ormai, e volevamo fosse bella, accogliente.
Tre grandi stabilimenti hanno chiuso in questa zona, centinaia di migliaia di metri quadrati, gli spazi sono rimasti per un bel po’senza controllo e abbandonati, degli edifici sono rimasti solo scheletri di ferro e cemento. E silenzio.

Questo quartiere faceva paura a tutti, questa Brescia così poco fuori dal centro faceva impressione. Molte voci diverse hanno contribuito ai cambiamenti nel quartiere, anche se non tutte sono state ascoltate. Le opinioni sono contrastanti, ma io ho sempre visto nelle chiusure, nell’abbandono delle fabbriche, nei cantieri sospesi non la fine di una storia, bensì l’inizio di una trasformazione.
Quelle fabbriche ora respirano di nuovo. Dove prima c’erano silenzi, ora ci sono voci, musica, luce. Hanno aperto un teatro, un centro culturale, una biblioteca, spazi che accolgono storie invece della polvere.
Tra le aperture di spazi nuovi, quello che io frequento di più è La Casa del Quartiere in via Milano.
In Marocco diciamo “Se fai del bene, fallo bene”. Ho 60 anni, faccio l’operaio, ma volevo rendermi utile anche io in questa trasformazione. Allora sono andato lì, alla Casa del Quartiere di via Milano, a curiosare, ad affacciarmi. E ho scoperto tutto il mondo lì a immaginare, a tracciare un futuro e una trasformazione fatta di vicinanza umana, di contatto, di calore. Una grande coperta realizzata con stoffe e ricami di tutto il mondo, capace di abbracciare una famiglia intera. Ho scoperto una musica che si può ascoltare anche quando esci da lì, perché quel dondolare di lingue e di storie, ti resta dentro, come un tormentone dell’estate italiana. E allora ho iniziato a ballare e a fare il volontario. La Casa del Quartiere accoglie tantissime persone e di tante nazionalità che qui vengono aiutate o aiutano a loro volta: donne, bambini, uomini. In via Milano c’è la scuola d’italiano, il doposcuola, il teatro, una biblioteca. C’è perfino una “sartoria dell’allegria”, anche mia moglie ci va!
In via Milano, ci sono le voci del quartiere, i figli, i papà, le mamme, e tutti che preparano il futuro come fosse una teglia di biscotti per amici, famiglia, vicini di casa. Un futuro condiviso.
Tante delle persone che arrivano qui provengono da nazionalità e continenti lontani, questo quartiere accoglie tutto il mondo. Io vengo dal Marocco per esempio, ma ora questa è la mia casa. Che questo quartiere sia considerato brutto o meno, è la mia casa, e di tutti quelli che qui hanno vissuto e vivono. È il respiro di chi l’ha abitata e di chi la abita, il fremito continuo di una comunità che cambia.
In Marocco diciamo: “Se fai del bene, fallo bene”, e ci proviamo pure qui.
Cristiano, della Casa del Quartiere, mi chiamò quella mattina.
“Kareem, lui è Ramon, viene da Cuba, ha 22 anni, ascolta la sua storia” così me lo presentò.
Guardai Ramon. I suoi occhi sbucavano come lampi timidi dal viso stanco. Questo ragazzo non dormiva bene. Provai di nuovo quella sensazione: un graffio al cuore, improvviso, animale, che di getto ti fa gocciolare dentro.
Mi sedetti, per ritrovare la calma, e lo ascoltai.
Ramon era arrivato in Italia da pochi mesi, non aveva un posto per dormire, non aveva un lavoro. Era arrivato alla Casa del Quartiere in via Milano, perché aveva sentito dire che qui si accolgono tutti, ed in qualche modo lo avremmo aiutato.
La storia di Ramon era la mia storia.
Volevo aiutare la mia famiglia, perciò sono partito da Rabat. Ero giovane e pieno di speranze.
Sono arrivato a Roma, perché sapevo che era un posto buono da cui partire. Non avevo il permesso di soggiorno, non avevo un posto per dormire, non avevo un lavoro.
Mi sono arrangiato per un paio d’anni, facevo il lavavetri ai semafori. Dormivo nelle macchine, o per strada. Mi sentivo perso, senza sapere neppure dove lavarmi, dove andare in bagno.
A Rabat non avevo mai dormito fuori casa, in strada.
Mi sentivo inutile, mi mancava casa, la mia famiglia. Mi veniva da piangere, ma non potevo, allora le lacrime le ricacciavo negli occhi e continuavamo a lavare i vetri delle auto.
Di casa vedevo solo quelle vuote. Ci muovevamo in gruppo e cercavamo delle abitazioni abbandonate, dove nasconderci e poter dormire qualche ora. Dormivamo sempre con le scarpe, per scappare in fretta se arrivavano controlli. Una notte ci hanno sopresi, io allora ho cominciato a correre forte, fortissimo, per strada sfrecciavo, senza vedere più nulla di quello che mi stava attorno, come fossi stato nel buio di un deserto.
All’improvviso una voce romana, forse da una macchina che sfrecciava accanto a me: “A Mennea, ma ndo corri”?
Mi sono fermato all’istante, immobile, come un’animale che si accorge del suo cacciatore, sentivo l’eco del mio battito, il brivido è diventato sudore sul viso, che scorrendo caldo giù per il collo e il petto si è trasformato in una grassa risata. E ho riso, riso, riso così tanto che il cuore dalla gola è finito nella pancia e lì si è confortato.
Non mi avevano preso, contava questo. E quella risata mi portò fortuna.
Di lì a poco ottenni finalmente il permesso di soggiorno, lo strinsi in tasca. Ora potevo andare dove volevo, cercare un posto dove rinascere e che fosse finalmente casa.
Volevo lavorare, avere un impego serio, stabilirmi in una comunità. Mi fu subito chiara una direzione.
Il giorno dopo presi il treno e andai a Brescia, li c’era lavoro, c’erano le fabbriche.
La mattina che incontrai Ramon a via Milano, riconobbi quel senso di smarrimento che avevo provato anche io, quel tremore della pelle di chi sta cercando riparo. Non ho fatto altro che pensare a lui nei giorni successivi, a come poterlo aiutare. Non l’ho aiutato da solo, impossibile fare da soli cose come queste, ma insieme alla comunità, coinvolgendo la comunità, la Casa del Quartiere. Siamo riusciti a trovare una casa per lui e un lavoro, perché avesse la possibilità di rinascere, di rigenerarsi, come avevo fatto anche io venendo a Brescia.
Aiutare non è un gesto distante. È qualcosa di più profondo, più crudo, più vero. Aiutare è mettersi la pelle dell’altro addosso, sentire sulla propria carne i suoi graffi. È lasciare che la sua voce entri dentro, che il suo sguardo ti attraversi, che il suo dolore si mescoli, anche solo per un istante, con il tuo.
Chi chiede aiuto non lo fa a cuor leggero. Dietro quella richiesta c’è sempre un’urgenza, una necessità che non può aspettare. E in quei momenti non puoi girarti dall’altra parte, non puoi voltarti indietro fingendo di non aver visto.
Aiutare significa esserci, senza esitazioni. Significa riconoscere nell’altro un pezzo di te stesso, accogliere la sua fragilità come fosse la tua. Non per compassione, ma per condivisione. Perché se quel dolore lo senti davvero, se ti scorre dentro, allora non sei più solo un testimone. Sei parte della sua storia, e lui della tua. E le storie sussurrate a via Milano sono tante, dal mondo o dalla porta accanto, poco importa, aiutare ha sempre lo stesso colore.
Fare del bene e farlo bene è un’energia che scorre, un filo invisibile che lega chi dona e chi riceve, trasformandoli entrambi. È una rinascita condivisa, un battito che si moltiplica: in due, in quattro, in dieci, in cento. Così nascono le comunità. Così è La Casa del Quartiere, una casa che non smette mai di allargare le sue pareti, un luogo dove ci si tende la mano, ci si sostiene, ci si rialza insieme.
“Questa è una nuova Brescia?” mi hanno chiesto. Non lo so. So che via Milano è la mia danza, il mio colore, la mia casa, la mia famiglia. E come in ogni famiglia, le voci a volte si sovrappongono, altre si scontrano, altre si fondono, ma in quel trambusto ti va sempre di restare.
E se ogni giorno ancora qualcuno bussa alla porta e chiede aiuto, vuol dire che non abbiamo fatto tutto. Vuol dire che possiamo fare meglio. Tutti.
“Se fai del bene, fallo bene” dicono in Marocco, e pure a via Milano, a Brescia.
APPROFONDISCI
Il racconto di Emilia Martinelli si può ascoltare nella lettura di Sandro Calabrese (cliccare qui)
Leggi gli altri articoli della rubrica "Rigenerazione Umana"
Emilia Martinelli
 Nata a Napoli nel 1974, storyteller nell’ambito della valorizzazione di beni culturali, regista e autrice, insegnante di teatro, educatrice. Il lavoro di autrice parte sempre da ricerche sul campo, dall’ascolto di storie vere. Collabora e ha collaborato col Teatro Brancaccio, il Teatro di Roma. Ha lavorato anche in contesti “al limite” come carceri, centri di accoglienza, periferie, e poi con donne vittime di violenza, persone disabili, minori a rischio. È fondatrice e direttrice artistica della compagnia fuori contesto dal 2005 e dal 2013 del Festival “Fuori Posto. Festival di Teatri al limite”. Dal 2020 è socia della società̀Hubstract Made for art e cura i contenuti, le installazioni e performance site specific.
Nata a Napoli nel 1974, storyteller nell’ambito della valorizzazione di beni culturali, regista e autrice, insegnante di teatro, educatrice. Il lavoro di autrice parte sempre da ricerche sul campo, dall’ascolto di storie vere. Collabora e ha collaborato col Teatro Brancaccio, il Teatro di Roma. Ha lavorato anche in contesti “al limite” come carceri, centri di accoglienza, periferie, e poi con donne vittime di violenza, persone disabili, minori a rischio. È fondatrice e direttrice artistica della compagnia fuori contesto dal 2005 e dal 2013 del Festival “Fuori Posto. Festival di Teatri al limite”. Dal 2020 è socia della società̀Hubstract Made for art e cura i contenuti, le installazioni e performance site specific.