SUPERBONUS/PERCHE' NO
Con quei fondi spesi per il 110% avremmo dovuto fare investimenti pubblici utili a TUTTI
Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) per incentivare interventi di efficientamento energetico, antisismico e installazione di impianti fotovoltaici negli edifici. E’ stato utilizzato perlopiù per interventi di efficientamento energetico e in maniera marginale per interventi di tipo antisismico. Ha riguardato circa 500 mila edifici, per circa 1 milione di unità abitative, con un costo medio di investimento di circa 112 mila euro. Si tratta di circa il 3,9% delle unità abitative presenti in Italia. Il costo complessivo per lo stato è di circa 123 miliardi i tre anni. Se si sommano anche i bonus edilizi di altro tipo si arriva ad un volume di risorse intorno ai 190 miliardi.
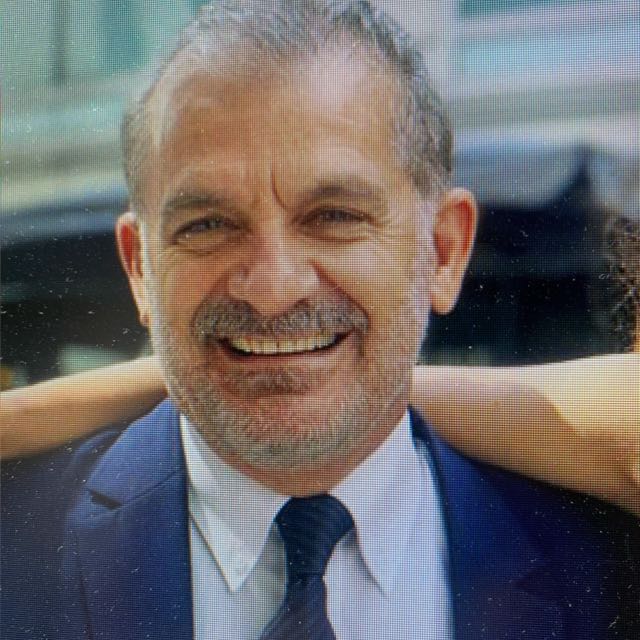
Si può ben parlare che in Italia si è avuto un raddoppio del PNRR in un tempo quasi dimezzato.
Ovviamente se il PNRR e i Superbonus edilizi si fossero “sommati” in una sorta di “investimento aggiuntivo” del paese l’impatto sarebbe stato di scala incommensurabile rispetto a quello che è successo. Sia il PNRR che il Superbonus hanno coperto interventi e spese che sarebbero state fatte ugualmente, diminuendo così l’impatto reale sul sistema economico.
Ma veniamo agli elementi critici che possiamo segnalare su questo strumento di intervento, tralasciando, dopo una breve esposizione, il tema positivo dell’impatto sull’economia in quanto ogni intervento pubblico di investimento, su qualsiasi settore, avrebbe avuto più o meno lo stesso impatto economico, a parità di tempo di realizzazione delle opere e scartando settori ad alto contenuto intrinseco di importazione dall’estero. Cosi’ come la spesa in qualsiasi altro settore si sarebbe risolta, alla fine del ciclo, in un ritorno allo Stato di circa il 40/45% dell’impatto aggiuntivo sull’economia sotto forma di imposte e contributi.
L’impatto c’è stato, la spesa è stata celere, e questo è forse l’unico elemento positivo anche se certamente non esclusivo di questo strumento, e il Superbonus ha certamente aggiunto la “propria” spinta alla spinta degli altri settori economici che uscivano dalla crisi pandemica. Si può dire che il 20% circa della crescita economica dal 2021 al 2023 può essere assegnata all’impatto del Superbonus: 1,7% nel 2021, 0,9 nel 2022 e 0,2 nel 2023.
Ma al posto della spesa per interventi per lo più privati, con una quota non rilevante di bene pubblico legato alle emissioni e al risparmio energetico, questa spesa poteva essere plurisettoriale (sanità, acqua e ambiente, smart city, economia circolare, infrastrutture verdi, digitalizzazione e ricerca pubblica, etc) e fortemente diretta ad aumentare il capitale pubblico del paese. In un prossimo libro con Erasmo D’Angelis presentiamo un Piano per la sicurezza idrica e idrogeologica del paese: 176 miliardi in dieci anni. Non sono discorsi tanto per fare.
Aver puntato su un solo settore ha creato non pochi problemi di scarsità di capacità produttiva, mancanza di materiali e servizi avanzati di supporto. L‘effetto sii prezzi è la naturale conclusione di una scelta sbagliata. Il settore delle abitazioni è stato quello dove i prezzi sono cresciuti di più: il 15% dal 2020 a fronte di un 6% negli altri settori di investimento.
Tale spinta è stata resa ancora più forte a causa della “sciagurata” quota di contribuzione, il 110% della spesa, che ha teso a togliere dalla normale e salutare contrattazione di un bene fra venditore e compratore il ruolo del secondo. Che, di solito, fa abbassare il prezzo ed innalzare la qualità del bene venduto.
Ed alla fine cosa è stato raggiunto a fronte di un volume di spesa pubblica elevatissima e fuori controllo e per molti versi imprevista? Considerando che l’energia per le abitazioni è responsabile di un 16% di emissioni e considerando che lo strumento ha riguardato appena il 4% delle abitazioni, si può dire che il “target” ambientale ha riguardato appena lo 0,6% delle emissioni. Se ammettiamo un risparmio del 30% possiamo dire che, a grandi linee, lo strumento ha cancellato lo 0,2% delle emissioni. Mettiamoci anche un risparmio marginale della spesa energetica delle famiglie e possiamo comprendere come si sia risolto tutto nell’utilizzo di un “cannone per sparare ad un muretto cadente”.
Inutile fare una valutazione costi benefici: i costi sono alti , e talvolta truffaldini a causa dell’eccesso di contribuzione che favoriva il raggiro, mentre i benefici, laddove ci sono, sono prevalentemente di natura privata e per piccola quota di natura pubblica.
Non voglio parlare degli effetti redistributivi “al contrario”: le regioni che hanno sfruttato di più lo strumento sono Lombardia, Veneto , Emilia, Toscana, Lazio. Non proprio le più povere. E le famiglie rappresentano in maggioranza la parte medio alta della distribuzione della ricchezza nazionale. Insomma, come era facile prevedere, sono state le aree meno disagiate a superare le difficoltà burocratiche e tecniche per sfruttare il contributo.
Insomma uno strumento da non replicare. Una esperienza da non ripetere. Una spesa pubblica veramente male indirizzata.

