L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP / 6
Renzo Piano il Re, bravo e pigliatutto: i tre periodi, le architetture capolavoro e le opere meno riuscite
Renzo Piano è l’architetto più noto e apprezzato in Italia. Era prevedibile che una monografia a lui dedicata inaugurasse la collana di libri sui maestri dell’architettura e del design distribuita con il Corriere della Sera. Ed era ugualmente prevedibile che suscitasse alcuni interrogativi. Per esempio, sulla direzione che sta prendendo la sua opera dopo un primo periodo segnato dall’High Tech e un secondo dal prevalere del metodo sulla forma.
Il primo Renzo Piano era emerso nella ribalta internazionale per il disinvolto uso della tecnologia. Un approccio che aveva sperimentato con il centro Pompidou a Parigi (1971/1977), disegnato in collaborazione con Richard Rogers e Gianfranco Franchini, caratterizzato da tubi. impianti e una scala mobile, messi in vista in facciata.

Luigi Prestinenza Puglisi

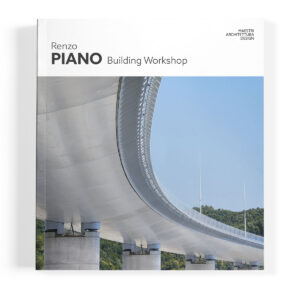 Con le opere degli anni successivi, Piano mostra un atteggiamento più pacato ma con molteplici e a volte contraddittori riferimenti stilistici e formali. Così, per esempio, troviamo ad Amsterdam il NEMO, un edificio a forma di Nave (1990/1997); a Rotterdam il KPN Telecom Office Tower con la facciata illuminata da pixel come se fosse lo schermo di un computer (1997/2000); a Roma la Città della Musica con tre sale bloboidali rivestite in lastre di piombo (1995/2002); in Nuova Caledonia Il Centro culturale Jean-Marie Tjibaou (1995/1998), costituito da elementi a forma di capanna liberamente ripresi dalla tradizione locale.
Con le opere degli anni successivi, Piano mostra un atteggiamento più pacato ma con molteplici e a volte contraddittori riferimenti stilistici e formali. Così, per esempio, troviamo ad Amsterdam il NEMO, un edificio a forma di Nave (1990/1997); a Rotterdam il KPN Telecom Office Tower con la facciata illuminata da pixel come se fosse lo schermo di un computer (1997/2000); a Roma la Città della Musica con tre sale bloboidali rivestite in lastre di piombo (1995/2002); in Nuova Caledonia Il Centro culturale Jean-Marie Tjibaou (1995/1998), costituito da elementi a forma di capanna liberamente ripresi dalla tradizione locale.
Tecnologie e forme, sostiene Piano, sono come l’autobus che prendi sino al punto in cui vuoi andare. Poi scendi e, quando ti serve di nuovo, sali su un altro. La coerenza è da ricercarsi nel metodo. E nell’obiettivo che è l’umanizzazione della tecnologia. Gli edifici di Piano si caratterizzano tutti, infatti, per il loro essere alla scala umana e per la precisione del dettaglio. Tanto che in quegli anni sono stati messi dalla critica in contrapposizione con le opere più scultoree progettate da Massimiliano Fuksas, per il quale il dettaglio gioca un ruolo minore per far posto ad una gestualità e a una capacità di rapportarsi con il contesto paesaggistico che, invece, in Piano non è sempre così evidente.
Il terzo periodo è caratterizzato da una intensa e originale ricerca di unità stilistica. Gli edifici sono più curati nelle forme e nei materiali. Come per esempio nella fondazione Beyeler vicino a Basilea in Svizzera (1991/1997) caratterizzata da un rivestimento in pietra, da una vasca d’acqua dove l’architettura si riflette e sembra vibrare e, infine, da un tetto aggettante e leggero. Il metodo sembra aver fatto un passo indietro, la ricerca della bellezza uno avanti.
A catturare in questi anni l’interesse di Piano sono i rivestimenti metallici, il color bianco, le vetrate trasparenti, i pilastri slanciati, le sottili coperture aggettanti. Queste ultime esaltano la dimensione orizzontale, suggerendo un’idea di leggerezza e, insieme, di protezione e accoglienza, memori di suggestioni che ricordano le architetture minimaliste di Mies van der Rohe e i piani che si librano nello spazio del movimento olandese De Stijl. Degli undici progetti scelti per illustrare il volume, numerosi hanno queste caratteristiche della terza fase, segno che Piano una sua peculiare cifra stilistica la ha effettivamente trovata. Anche se, accanto alle opere nel nuovo stile Piano, non mancano edifici con forme molto diverse come per esempio la curviforme Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé (2011/2014) o il materico palazzo del Parlamento a Malta (2011/2015) che però non compare nel libro. Edifici-testimonianza della versatilità dell’architetto il quale non perde occasione per trovare eccezioni a un proprio stile altrimenti eccessivamente unificante.
Il libro è interessante per diversi altri motivi. Il primo è per la scelta, molto discutibile, di mettere in copertina una grande foto del controverso viadotto progettato da Piano a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova. Un progetto discusso e criticato per le modalità di assegnazione dell’incarico. Un viadotto di scarso interesse architettonico che, con notevole presunzione, ha voluto prendere il posto di un capolavoro che poteva essere recuperato. Perché selezionarlo allora tra le 11 sue opere più importanti? Forse per gonfiare il valore estetico e l’importanza strategica dell’opera disegnata da Piano e così giustificare ciò che, a mio personale giudizio, è ingiustificabile: l’abbattimento di una testimonianza unica dell’ingegneria italiana come il Morandi (avreste mai abbattuto l’intera San Pietro a seguito del crollo di una navata?).
Un’operazione di comunicazione questa, firmata dalla curatrice della collana, ma che dubito possa essere stata fatta senza l’assenso dell’architetto genovese.
Il secondo motivo di interesse lo troviamo nella scelta di inserire nel libro un’opera di Piano che ha suscitato molte perplessità e le ire di uno dei più importanti critici internazionali di Architettura, William Curtis. Si tratta della sistemazione del centro visitatori del monastero di Santa Chiara nelle vicinanze della chiesa di Ronchamp, opera celeberrima di Le Corbusier. L’intervento di Renzo Piano è stato discreto e quasi in punta di piedi ma, come ha notato il critico anglo-francese, non abbastanza; e ha trasformato il luogo, che prima aveva un suo fascino mistico, dato proprio dalla sua mancanza di organizzazione, in uno spazio turistico come ce ne sono tanti. La sua riproposizione in questa antologia delle 11 opere migliori, indica che per lo studio Piano non ci sono motivi di pentimento.
Il terzo edificio problematico è lo Shard, il più alto grattacielo europeo. Un’opera gigantesca di sia pur legittima speculazione edilizia passato come un intervento con finalità ecologiche perché al suo interno è previsto solo un numero estremamente limitato di parcheggi e per la sua forma destrutturata, da scheggia appunto che un po’ lo smaterializza. Un edificio sul quale si dovrebbe discutere molto. E che ci dovrebbe ricordare che Piano non è semplicemente autore di opere ad alto contenuto culturale, come musei e auditori, o meritorie, come l’ospedale pediatrico Fondazione Seràgnoli a Bologna (2014/2024) o prestigiose come il CERN a Ginevra (2018-2023), ma anche di corposi interventi di edilizia speculativa, come per esempio la nuova penisola artificiale di Montecarlo che occupa alcuni ettari del Mar Mediterraneo con abitazioni vendute a oltre 100.000 euro al metro quadrato, o i grattacieli sparsi per il mondo come le due torri del 565 Broome Soho a New York.
Nessun moralismo, ma semplicemente per capire quanto mostre e libri su Piano, tra i quali questo stesso volume, affrontino solo una parte della produzione dello studio, quella che è più facilmente comunicabile e che è preferibile divulgare. E quanto la retorica dell’architetto artigiano sia una abile strategia di posizionamento nel mercato dell’architettura, una strategia non dissimile da quella di molti marchi commerciali che hanno optato per una comunicazione con parole – artigianalità, sartorialità, misura umana, su misura – simili.
Un ultimo motivo di interesse è che nel risvolto della copertina del libro appaiono i nomi dei partner del Renzo Piano Building Workshop in ordine di anzianità. Segno forse che l’architetto, che è nato nel 1937 e quindi va per gli 88 anni, comincia a pensare alla successione. Sarà però difficile che un re che ha goduto di potere assoluto possa essere facilmente sostituito da ufficiali che, oltretutto, non sono abituati a stare sotto la luce dei riflettori.
Il libro è godibile, ben documentato e chiaramente scritto da Emanuele Piccardo, forse un po’ troppo preso dal personaggio Piano, tanto da paragonarlo a Filippo Brunelleschi. Verrebbe da dire con una battuta scherzosa che se Renzo Piano si fosse comportato con la copertura di Santa Maria del Fiore come con il Ponte Morandi, adesso al posto della arditissima cupola del Brunelleschi avremmo un bel soffitto orizzontale.
La cura della collana è di Marianna Guernieri. Che ha già annunciato le prossime monografie. Con scelte intriganti ma un po’ casuali e segnate da assenze di rilievo. Mancano, per esempio, Archea, Citterio e Viel, Benedetta Tagliabue, Cino Zucchi, Mario Bellini, Ettore Sottsass. I selezionati inoltre appartengono alle scuole più diverse e non sembrano essere stati scelti in relazione a un qualche criterio storico, stilistico o antologico. Pazienza, sono comunque progettisti interessanti. Il formato del libro è accattivante, le foto sono belle e a colori e il prezzo di 9 euro è invitante.
Leggi gli altri articoli della rubrica "L'Architettura vista da LPP"

