OGGI LA PRESENTAZIONE DEL 38° RAPPORTO CONGIUNTURALE
Cresme: nel 2025 altra correzione di mercato (-6,1%), ma il Pnrr dà RESILIENZA. “Servono 120mila case l’anno”
La contrazione di mercato prevista per quest’anno segue quella del 2024 (-2,7%) e continuerà nel 2026 (-2,1%). Nel 2028 la correzione dovrebbe arrivare, rispetto al picco del 2022, all’11,4%, pari a 21 miliardi a valori deflazionati. C’è però la tenuta del settore, fortificato dalla grande espansione del triennio 2021-2023. “La frenata del mercato – avvisa il Cresme – mantiene tuttavia la produzione su livelli importanti in chiave storica, come se il settore avesse fatto un salto di scala rispetto al recente passato in termini di potenzialità produttive”. Tra il 2019 e il 2024 il valore della produzione (compresa la manutenzione ordinaria) è cresciuto da 180 miliardi a 228 miliardi, con un incremento di 109 miliardi. Poco più di metà di questo valore, 56 miliardi, è però dovuto all’inflazione del settore, mentre 53 miliardi sono di crescita reale. C’è il rischio di un nuovo incremento dei costi di costruzione per effetto della guerra dei dazi.
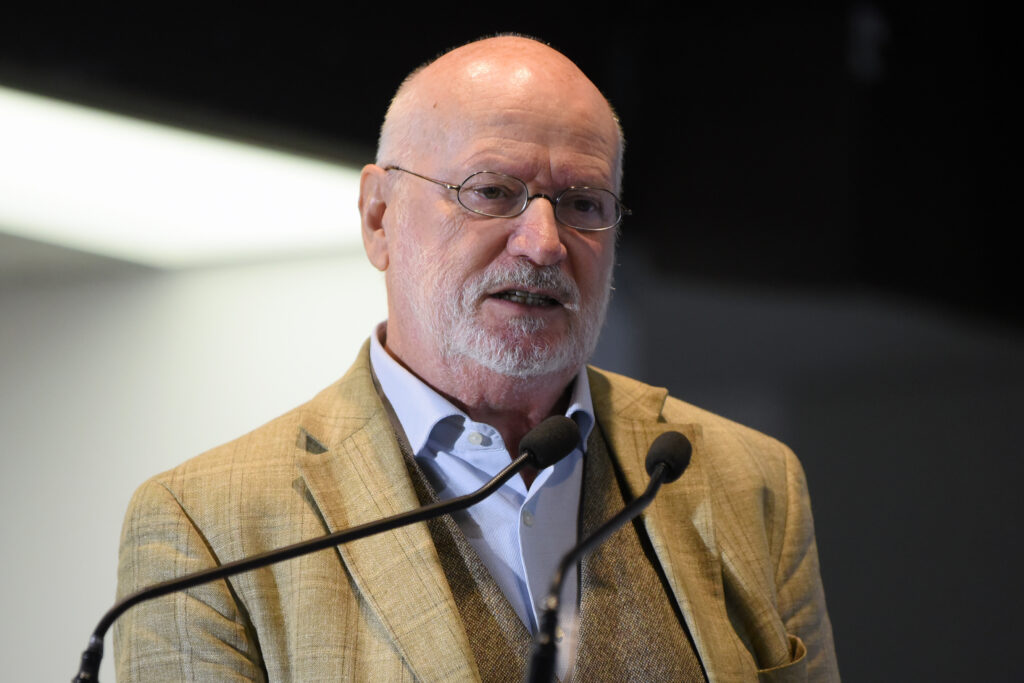
Lorenzo Bellicini, direttore Cresme
IN SINTESI
Continua la correzione del mercato delle costruzioni nel 2025 con un -6,1% che segue il -2,7% del 2024 e continuerà nel 2026 con una ulteriore contrazione di -2,1%. Complessivamente la correzione dopo il picco del 2022 dovrebbe arrivare all’11,4% nel 2028 per un valore (deflazionato) pari a 21 miliardi di euro. La contrazione congiunturale del mercato delle costruzioni tradotta in previsioni numeriche dal Cresme – che oggi presenterà online con il direttore Lorenzo Bellicini, il XXXVIII Rapporto congiunturale – è però solo una delle molte facce del settore. Il secondo elemento caratterizzante è la resilienza. “Il mercato ha mostrato nel triennio 2023-2025 – scrive il Cresme – una certa resilienza dovuta al prolungamento degli effetti dei bonus, che registrano esempi di contabilità diversa tra fatturazioni (anticipate) e lavorazioni (posticipate), e dall’altro all’eccezionale fase espansiva vissuta dalle opere pubbliche trainate dal Pnrr”.
Il traino del Pnrr
Il Piano europeo ha portato una crescita, in valori correnti, del settore del genio civile dai 37 miliardi del 2022 ai 53,4 miliardi del 2025 (+44%) e del settore non residenziale pubblico (scuole, ospedali, uffici, ecc.) da 14 miliardi a 24,5 miliardi (+75%). In volumi costanti la crescita del genio civile è stata del 21,2% nel 2023, del 10,7% nel 2024 e del 6,2% nel 2025, mentre per l’edilizia non residenziale pubblica è stata nei tre anni rispettivamente del +27,9%, +21,5% e +10,6%. Totale del comparto delle opere pubbliche: +27,9% nel 2023, +21,5% nel 2024 e +7,5% nel 2025. Anche per il 2026 l’attesa è positiva con una previsione di +5%.
Il crollo del rinnovo abitativo privato
Un solo numero basta, invece, per raccontare il crollo del mercato del rinnovo nel residenziale privato: -20,5% nel 2025. La ragione risiede unicamente nella sterilizzazione del Superbonus e nel sostanziale raffreddamento degli altri bonus. La discesa continuerà l’anno prossimo con -11,3%.
L’aumento dei costi: il passato e i rischi per il futuro
Il quadro del settore non può essere completo, però, senza il terzo fattore decisivo di questi anni: l’aumento dei costi. Il Cresme lo evidenzia a più riprese. Un aspetto importante è che peso e che ruolo ha avuto l’aspetto inflattivo nella grande crescita dal 2019 a oggi. Se si assume il valore della produzione, comprendendo anche la manutenzione ordinaria oltre agli investimenti (ma non gli impianti delle energie rinnovabili), si è passati dai 180 miliardi del 2019 ai 228 miliardi del 2024, con una crescita spettacolare di 109 miliardi in valori correnti, pari al +60,6% in termini percentuali. Il Cresme stima, tuttavia, che oltre la metà di questo incremento, 56 miliardi, sono dovuti all’inflazione di settore e 53 miliardi alla crescita reale che, in termini percentuali, si attesta a +26,8%. Ma c’è un altro aspetto dell’aumento dei costi che emerge guardando avanti: la fase di grande incertezza globale di questo momento e in particolare gli esiti non ancora valutabili della guerra dei dazi portano con sé vanno registrati “i rischi di un nuovo incremento dei costi di costruzione significativo dopo quello vissuto tra 2020 e 2022”.
I danni dell’assenza trentennale di una politica della casa
Un quarto fattore da tenere presente nel quadro delle incertezze e nelle previsioni di medio periodo è quello delle politiche per il settore del dopo-Pnrr. Politiche che oggi sono un’incognita pressoché totale, a partire dalle politiche abitative. Prima ancora di tentare una stima del fabbisogno abitativo – uno degli esercizi per cui il Cresme viene chiamato da ogni parte d’Italia per l’autorevolezza dei suoi sistemi informativi – il Rapporto congiunturale ricorda come l’assenza quasi trentennale di una politica abitativa nazionale abbia portato anche all’abbandono di quel “percorso complesso” che è la “costruzione della domanda abitativa”. Nel nostro Paese – evidenzia il Cresme – “ormai da tempo non viene più esercitato su scala nazionale”. E il Rapporto ricorda i fondamentali di un esercizio che il Cresme continua a fare per molte realtà locali: “Quante sono le case che servono? Che tipologie di case servono? Con tutte le case vuote perché esiste ancora il problema abitativo? Dove servono le case? Se ci sono tante case vuote perché domanda e offerta non si incontrano?”.
La stima del fabbisogno abitativo
La questione della casa è tornata ormai a livello europeo, “in particolare quella degli affitti e delle fasce deboli della domanda”. Il Rapporto non si sottrae quindi all’esercizio del fabbisogno abitativo, anche se avverte: “rispondere a queste domande non è certo facile, servirebbero ben altre risorse, soprattutto alla luce dei nuovi ingredienti del mercato, ma è possibile provare a disegnare alcuni aspetti del problema”. E arriva a un risultato che, in estrema sintesi, si può riassumere così, dopo alcune pagine di elaborazioni: “considerando la domanda pregressa che possiamo collocare intorno alle 500.000 unità e quella proveniente dalle 700.000 nuove famiglie che sono stimate crescere nei prossimi anni, il fabbisogno abitativo in Italia si determinerebbe il 1,2 milioni di abitazioni da costruire. In dieci anni 120.000 abitazioni all’anno”.

